 «Non esiste più la via di mezzo. C’è la gente che ha tutto e quella che non ha più niente». È l’amareggiato commento di un proprietario di un’abitazione, appartenente alla vecchia middle-class, che attende l’arrivo degli ufficiali giudiziari che gli notificheranno lo sfratto per morosità. L’alter ego di questo cittadino americano che lotta per la sopravvivenza è il titolare dell’agenzia immobiliare Gli avvoltoi degli appartamenti. Per detta dello stesso titolare «l’avvoltoio rappresenta l’ultimo anello della catena alimentare che arriva e ripulisce la carcassa».
«Non esiste più la via di mezzo. C’è la gente che ha tutto e quella che non ha più niente». È l’amareggiato commento di un proprietario di un’abitazione, appartenente alla vecchia middle-class, che attende l’arrivo degli ufficiali giudiziari che gli notificheranno lo sfratto per morosità. L’alter ego di questo cittadino americano che lotta per la sopravvivenza è il titolare dell’agenzia immobiliare Gli avvoltoi degli appartamenti. Per detta dello stesso titolare «l’avvoltoio rappresenta l’ultimo anello della catena alimentare che arriva e ripulisce la carcassa».
Ecco, lui fa questo: raccoglie i dati sulle case già pignorate al fine di carpirle ai proprietari in difficoltà finanziarie, per poi rivenderle facendo profitti. Perché tutti cercano di trarre profitto dalle disgrazie altrui. Questo è il capitalismo.
La libera impresa dovrebbe determinare il successo dei migliori. Coloro cioè che riescono a trovare il miglior punto di equilibrio tra la domanda e l’offerta, quelli che riescono a coniugare prodotti e servizi migliori al prezzo più basso, quelli che come premio per aver trovato la ricetta vincente raggiungeranno il successo. E da cosa si misura il successo? Dal profitto. E cosa si ottiene col profitto? Una vita agiata. E cosa comporta una vita agiata? Il consumismo. E un paese consumista cosa alimenta? Il capitalismo.
 E così si torna al punto di partenza. Perché la via del successo ha un prezzo che qualcuno deve necessariamente pagare. In genere si tratta del più povero, di chi non ha mai avuto la sua fetta di torta. «Ecco un uomo che ha solo quattro cubiti come gli altri, ed è a carico della Provvidenza come se l’avesse fornito di mille corpi» dice il barone Charles-Louis de Montesquieu in Storia vera, «Quanti uomini si sazierebbero dei cibi che ho visto presentare alla sua tavola? […] occorre una quantità innumerevole di donne per i suoi piaceri o le sue sazietà. Il suo corpo ha pochi bisogni, ma il suo spirito li moltiplica e, non potendo godere che di piaceri assai limitati, immagina di godere di tutti quelli dei quali priva gli altri».
E così si torna al punto di partenza. Perché la via del successo ha un prezzo che qualcuno deve necessariamente pagare. In genere si tratta del più povero, di chi non ha mai avuto la sua fetta di torta. «Ecco un uomo che ha solo quattro cubiti come gli altri, ed è a carico della Provvidenza come se l’avesse fornito di mille corpi» dice il barone Charles-Louis de Montesquieu in Storia vera, «Quanti uomini si sazierebbero dei cibi che ho visto presentare alla sua tavola? […] occorre una quantità innumerevole di donne per i suoi piaceri o le sue sazietà. Il suo corpo ha pochi bisogni, ma il suo spirito li moltiplica e, non potendo godere che di piaceri assai limitati, immagina di godere di tutti quelli dei quali priva gli altri».
In economia i bisogni si distinguono in primari e secondari. Tra quelli primari spiccano i bisogni di nutrirsi, ripararsi, vestirsi, difendersi. Si tratta di bisogni irrinunciabili. Soltanto dopo avere soddisfatto questi bisogni, gli individui cercheranno il soddisfacimento degli altri, sebbene altrettanto necessari per lo sviluppo armonico della persona. Orbene, se un individuo possiede un reddito sotto la soglia necessaria per soddisfare i bisogni primari, tenderà a risolvere il problema adottando uno stile di vita che gli permetta di sopravvivere. Ne consegue che, crescendo il reddito, l’individuo – in modo esponenziale – si distaccherà dal pensiero della sopravvivenza e si dedicherà ai bisogni secondari. Infine, accumulerà e risparmierà il superfluo.
Se tutto ciò non è compatibile con il capitalismo, com’è possibile che gli operai delle catene di montaggio degli anni sessanta e settanta stavano meglio di quelli del nuovo millennio ed avevano addirittura un sogno nel quale confidare? Quello non era il capitalismo?
 Su questi temi s’interroga Michael Moore nel suo documentario Capitalism: A Love Story, indagando sulle radici di un fenomeno che ha stravolto i rapporti etici, morali ed economici di una nazione che credeva nella verità evidente della ricerca della felicità.
Su questi temi s’interroga Michael Moore nel suo documentario Capitalism: A Love Story, indagando sulle radici di un fenomeno che ha stravolto i rapporti etici, morali ed economici di una nazione che credeva nella verità evidente della ricerca della felicità.
Ma sì, anzi era proprio amore per il capitalismo: la luna di miele tra una società che produce e lavora e cittadini che competono nella corsa verso il benessere. Però, c’è un però: in quegli anni, negli Stati Uniti, erano previste aliquote d’imposta molto alte, sino ed oltre al 90 per cento, sui redditi dei più ricchi. E ciononostante i ricchi continuavano a stare bene, perché pagavano tasse prelevando dal superfluo. Il risultato era che con quelle imposte si costruivano strade, aeroporti, dighe. Per costruirle occorrevano le imprese che necessitavano di manodopera. Gli operari a loro volta mettevano in circolazione il denaro e si generava un circolo virtuoso che non aveva bisogno di incoraggiamento o di iniezioni di fiducia, né di piazzisti della politica dell’ottimismo porta a porta, perché la tendenza a creare qualcosa di meglio intorno a sé è naturale negli uomini, altrimenti vivremmo ancora tutti nelle caverne.
La luna di miele terminò quando giunsero alcuni leader politici, tra cui Ronald Reagan, sostenitori del motto: «Se il profitto non è un male, perché non incentivarlo?». Purtroppo, però, le regole che valgono per i singoli o per le imprese, non sempre valgono per uno Stato. Il risultato fu che si incentivarono gli interessi delle lobbies economiche a danno delle rivendicazioni sindacali, si chiesero rinunce alle classi meno agiate, si operarono tagli e licenziamenti e i lavoratori superstiti dovettero produrre di più. E la qualità, che fine fece?
 Susan, pilota di una compagnia aerea regionale, guadagna 19.000 dollari l’anno. Per arrotondare, porta a spasso i cani o distribuisce succhi di frutta. Joe, anch’egli pilota, ha dovuto ricorrere ai buoni alimentari. Entrambi hanno un debito di circa 100.000 dollari da ripianare. Joe sostiene che ci sono parecchi colleghi che donano il sangue a pagamento. Il marito di Irma Johnson è morto di cancro. La Amegy Bank, azienda per la quale lavorava, aveva contratto una polizza sulla sua vita da 1.500.000 di dollari. In un regime capitalista un dipendente può valere più da morto che da vivo. Non certo per Irma che è rimasta senza alcun sostegno economico. Davvero la società vuole che gli uomini che lavorano per migliorare la qualità della nostra vita debbano contare le monetine per arrivare a fine mese?
Susan, pilota di una compagnia aerea regionale, guadagna 19.000 dollari l’anno. Per arrotondare, porta a spasso i cani o distribuisce succhi di frutta. Joe, anch’egli pilota, ha dovuto ricorrere ai buoni alimentari. Entrambi hanno un debito di circa 100.000 dollari da ripianare. Joe sostiene che ci sono parecchi colleghi che donano il sangue a pagamento. Il marito di Irma Johnson è morto di cancro. La Amegy Bank, azienda per la quale lavorava, aveva contratto una polizza sulla sua vita da 1.500.000 di dollari. In un regime capitalista un dipendente può valere più da morto che da vivo. Non certo per Irma che è rimasta senza alcun sostegno economico. Davvero la società vuole che gli uomini che lavorano per migliorare la qualità della nostra vita debbano contare le monetine per arrivare a fine mese?
Molti sono convinti che l’amore per il capitalismo si possa sposare perfino con i principi cristiani. Ma non sono esattamente queste le parole della Bibbia: «Ti prego Maestro, dimmi: cosa devo fare per avere la vita eterna?», «Va’ e massimizza i tuoi profitti». Neppure: «Tu dici che il regno dei cieli è vicino. Ma quando verrà esattamente?», «Quando deregolamenterete il sistema bancario». E neanche: «Salvami! Sono in queste condizioni da vent’anni», «Mi dispiace ma dovrai pagare di tasca tua». Eppure molti capitalisti si professano persone religiose e credono nella benedizione di Dio sulle loro fortune. Se così fosse, Dio avrebbe permesso lo sviluppo della plutonomia, una società controllata da una popolazione dell’1 per cento che possiede il 95 per cento delle ricchezze di uno Stato, come confermato da un rapporto della Citibank.
«Nessun uomo dovrebbe possedere più di quanto gli sia necessario per vivere; il resto di diritto appartiene allo Stato», diceva Benjamin Franklin. «La proprietà monopolizzata o in possesso di pochi è una maledizione per l’umanità», sosteneva John Adams. Eppure l’America ha preso un’altra strada.
 Una storiella narra che un giorno una regina disse: «Il popolo non ha pane? Diamogli le brioches!». Così poteva parlare un sovrano. Adesso è il popolo sovrano. La domanda è: allora i politici cosa sono?
Una storiella narra che un giorno una regina disse: «Il popolo non ha pane? Diamogli le brioches!». Così poteva parlare un sovrano. Adesso è il popolo sovrano. La domanda è: allora i politici cosa sono?
Il rapporto Citibank sostiene che i ricchi abbiano soltanto l’1 per cento dei voti e i poveri il restante 99 per cento. Le percentuali dunque sono ribaltate: una cosa è il capitalismo, un’altra è la democrazia. Se questo è vero, il capitalismo ha i giorni contati: la democrazia ha i numeri per vincere e le promesse non servono più a nessuno. È il momento delle scelte.
Si ringrazia per l’editing M. Laura Villani
Clicca qui se vuoi vedere come finisce questa storia
Clicca qui se invece vuoi sapere soltanto di cosa tratta questo film
Clicca qui se vuoi leggere una recensione collegata
- Skyfall, quando il cielo cade - 12 Novembre 2012
- Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, l’immagine del potere non può essere scalfita neanche di fronte all’evidenza - 21 Maggio 2012
- The Help e l’Oscar al femminile che forse non verrà - 20 Febbraio 2012

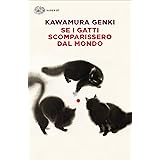




Caro Giuseppe, (purtroppo) condivido ciò che dici.
Il suffragio universale è una grande conquista della democrazia, ma come tutte le cose buone presenta anche il risvolto della medaglia.
Alexis de Tocqueville, il liberale francese che approfondì le origini delle moderne democrazie nel suo saggio La democrazia in America, aveva già intuito i pericoli insiti nella delegazione del potere alla raccolta della semplice maggioranza dei voti e riteneva che, nelle società democratiche vi potesse essere il rischio della «tirannide della maggioranza».
Egli diceva: «Vedo chiaramente nell’ eguaglianza due tendenze: una che porta la mente umana verso nuove conquiste e l’ altra che la ridurrebbe volentieri a non pensare più. Se in luogo di tutte le varie potenze che impedirono o ritardarono lo slancio della ragione umana, i popoli democratici sostituissero il potere assoluto della maggioranza, il male non avrebbe fatto che cambiare carattere».
La sua preoccupazione era quella che la maggioranza potesse imporre la volontà generale in modo del tutto irrazionale, semplicemente in quanto tale.
La sua paura non era infondata e prova ne furono le affermazioni dei regimi totalitari all’inizio del secolo scorso.
Arendt, ne Le origini del totalitarismo, sosteneva che il popolo debba essere distinto dalla massa: «La plebe è composta da tutti i declassati. In essa è rappresentata ogni classe della società. Perciò è così facile confonderla col popolo, che pure comprende tutti gli strati. Mentre nelle grandi rivoluzioni il popolo lotta per la guida della nazione, la plebe reclama in ogni occasione l’uomo forte, il grande capo. Essa odia la società, da cui è esclusa, e il parlamento, dove non è rappresentata. I plebisciti, con cui i dittatori moderni hanno ottenuto così eccellenti risultati, sono quindi un vecchio espediente degli uomini politici che capeggiano la plebe».
Dobbiamo qui dunque fare attenzione a non confondere la plebe con il popolo dei lavoratori e le classi sociali meno facoltose.
Nei regimi democratici moderni, la partecipazione politica si esercita attraverso il voto, ma «il vecchio adagio tutto il potere risiede nel popolo è vero solo per il giorno delle elezioni» diceva Arendt e «il risultato è che i cittadini devono o sprofondare in letargo, prodromo di morte della libertà pubblica, oppure conservare lo spirito di resistenza a qualunque governo abbiano eletto, poiché l’unico potere che conservano è il potere estremo della rivoluzione».
Ultimamente ha parlato di rivoluzione anche il compianto Mario Monicelli. Ma Arendt si preoccupa di precisare che «dal punto di vista terminologico lo sforzo di recuperare il perduto spirito rivoluzionario deve consistere, in certa misura, nel tentativo di sintetizzare nel pensiero, e combinare significativamente, ciò che il nostro attuale vocabolario ci presenta in termini di opposizione e contraddizione».
Oggi, dunque, non è necessario prendere nessuna Bastiglia.
Anche per quanto riguarda l’annichilimento delle menti ad opera della propaganda televisiva a mezzo modelli di vita che conducono gli uomini a rinchiudersi nel cerchio dei propri interessi personali, sono d’accordo con te.
E, guarda caso, l’argomento è trattato da un altro documentario, come nel caso di quello qua sopra.
Non ti stupirà che si tratti di questo:
http://185.148.116.211/~lettermaga/?p=10119
Ti ringrazio veramente tanto per il tuo intervento.
Un caro saluto.
Mi convinco, purtroppo, che la democrazia non si identifichi con il diritto al voto da parte di tutti, perchè un’ampia percentuale di votanti non è consapevole dei suoi diritti e non valuta i progetti migliori che demoliscano l’ingiustizia sociale… Non è il caso di proporre che il diritto a votare sia esercitato solo da chi dimostri di conoscere almeno i programmi dei partiti? E’ offensivo dire che l’imbecillità oggi è il risultato di una dose costante di morfina multimediale diffusa dalle TV commerciali? Sono davvero sfiduciato… e i potenti non hanno nulla da temere, perchè hanno convinto gli imbecilli che la vera ingiustizia sia quella di far loro del male…….