 «La gente vuole andare al cinema proprio per dimenticare l’incalzare degli avvenimenti. Non vuole che dallo schermo le piovano addosso lezioni politiche o etiche. La gente ne sa abbastanza della sua infelicità e non vuole sentirne parlare. Non vuole la pedagogia e l’indottrinamento. Vuole divertirsi. I film delle sale devono essere oggetti di consumo, come tutto il resto, in cui non vi sia traccia d’inquietudine, di malessere. Questo è il momento che attraversiamo. Insomma l’indifferenza, per non dire la diffidenza, non ha mai pungolato nessun ingegno.
«La gente vuole andare al cinema proprio per dimenticare l’incalzare degli avvenimenti. Non vuole che dallo schermo le piovano addosso lezioni politiche o etiche. La gente ne sa abbastanza della sua infelicità e non vuole sentirne parlare. Non vuole la pedagogia e l’indottrinamento. Vuole divertirsi. I film delle sale devono essere oggetti di consumo, come tutto il resto, in cui non vi sia traccia d’inquietudine, di malessere. Questo è il momento che attraversiamo. Insomma l’indifferenza, per non dire la diffidenza, non ha mai pungolato nessun ingegno.
Non è facile lavorare senza committenza, senza sapere per chi si lavora. Non abbiamo quella dello spettatore, che sta a guardare la televisione, né quella dei mediatori, poiché i distributori si sono ormai ridotti a gruppi di mercanti esigui, pericolanti, terrorizzati e ignoranti. Non abbiamo nemmeno il pungolo della critica, in genere esterofila, americanista, magari tutta presa dal culto del film dell’orrore, da altre bizzarrie, ma spocchiosa verso il film italiano ambizioso.
Per fare un film bisogna avere, oggi, molta follia e molto amore per il cinema. E questo è probabilmente, l’unico aspetto positivo della faccenda».
Sono le parole di Elio Petri tratte dal sito a lui dedicato www.eliopetri.net. Il regista di La classe operaia va in paradiso non avrebbe forse potuto immaginare che queste riflessioni amare si potessero perpetuare nel terzo millennio in un’Italia che avesse già attraversato tutte le fasi evolutive e involutive della modernizzazione dello stato, dalla crescita esplosiva dell’economia, alla costruzione dello stato sociale, alle privatizzazioni e alle liberalizzazioni, sino a giungere alla fine della lotta di classe, ma anche al punto più basso della parabola discendente sino alla crisi dei valori, all’annichilimento degli individui, alla riduzione di molte forme di protezione sociale e alla riunificazione dei cittadini in una sola unica grande categoria di nuovi poveri.
Infatti, la situazione a livello produttivo cinematografico sembra rimasta immutata: ancora oggi, i produttori sono preoccupati soltanto di fare cassa e stanno attaccati alla creatività, testando in continuazione il termometro del gradimento del pubblico al botteghino. E siccome l’italiano, ancora più preoccupato e sfiduciato, non vuole pensare ma ridere, tutto si cristallizza nella produzione di commedie demenziali nell’attesa di tempi nuovi che forse non verranno mai.
 Eppure il film di Elio Petri, proprio grazie all’immutato scenario culturale e sociale, oggi può definirsi un film attuale. Tanto più che i problemi dei lavoratori – e qui non s’intendono solo gli operai delle fabbriche – sopravvivono a 40 anni di progresso e declino della nostra nazione.
Eppure il film di Elio Petri, proprio grazie all’immutato scenario culturale e sociale, oggi può definirsi un film attuale. Tanto più che i problemi dei lavoratori – e qui non s’intendono solo gli operai delle fabbriche – sopravvivono a 40 anni di progresso e declino della nostra nazione.
Un film, del resto, non dovrebbe servire soltanto per fare divertire o riflettere per un paio d’ore, ma dovrebbe lasciare una traccia nel tempo, come un quadro, un poema, un sonetto, una melodia non si esauriscono con la durata della loro esposizione o esecuzione.
 Lulù Massa (Gian Maria Volonté), 31 anni, in fabbrica da 15, due intossicazioni da vernice, uno squarcio da ulcera nello stomaco, è un operaio metalmeccanico. Ogni giorno entra in fabbrica col piglio del bravo soldato. Lui gli ordini li esegue, non li discute. La proprietà ha firmato un contratto con la forza lavoro che, grazie agli accordi sindacali, prevede una retribuzione commisurata in parte al fisso e in parte al cottimo. Ciò significa che l’operaio più produce, più guadagna.
Lulù Massa (Gian Maria Volonté), 31 anni, in fabbrica da 15, due intossicazioni da vernice, uno squarcio da ulcera nello stomaco, è un operaio metalmeccanico. Ogni giorno entra in fabbrica col piglio del bravo soldato. Lui gli ordini li esegue, non li discute. La proprietà ha firmato un contratto con la forza lavoro che, grazie agli accordi sindacali, prevede una retribuzione commisurata in parte al fisso e in parte al cottimo. Ciò significa che l’operaio più produce, più guadagna.
Lulù in questo è imbattibile. Usa una tecnica personale per mantenere una concentrazione efficacissima: ripete a se stesso in modo ossessivo «Ogni buco, un pezzo. Ogni pezzo, un culo». Ma la sera, giunto a casa, è distrutto dai ritmi massacranti della produzione e si annienta davanti la tv, ignorando anche la sua compagna Lidia (Mariangela Melato).
Per questa sua attitudine, Lulù è malvisto dagli altri operai che lo considerano troppo vicino alla proprietà e alla dirigenza, in quanto i suoi ritmi di lavoro mettono in cattiva luce le prestazioni dei colleghi, ai quali – di conseguenza – vengono chiesti risultati e produzioni sempre più conformanti.
Un giorno, però, il macchinario al quale Lulù lavora si blocca. Lui cerca di porre rimedio estraendo il pezzo bloccato con la mano e finisce per perdere un dito. Da questo momento in poi la vita di Lulù cambia, non tanto per la mutilazione subita, quanto perché il trauma gli permette di elaborare meglio la situazione lavorativa e di vita.
Grazie alle visite al vecchio collega Militina (Salvo Randone), ormai pensionato in una struttura per la cura delle malattie nervose e mentali, si rende conto che quel sistema di vita stava portando anche lui sull’orlo del baratro della follia. Così comincia a lottare per l’abolizione del cottimo, incitando i suoi colleghi a prendere coscienza del loro stato.
 Nella nuova veste di capopopolo Lulù si assume rischi maggiori di prima, perché la proprietà non lo vede più di buon occhio e i sindacati non vogliono appiattirsi sulle richieste dei singoli operai.
Nella nuova veste di capopopolo Lulù si assume rischi maggiori di prima, perché la proprietà non lo vede più di buon occhio e i sindacati non vogliono appiattirsi sulle richieste dei singoli operai.
Alla fine di una lunga tensione, durante la quale Lulù finisce per perdere il posto di lavoro e il sostegno dei compagni, le assemblee dei lavoratori riescono a strappare la riassunzione di Lulù e la mitigazione delle prestazioni basate sul cottimo.
Il film termina con gli operai alla catena di montaggio, mentre Lulù racconta – tra i rumori assordanti della fabbrica – il sogno del compagno Militina che li incita a sfondare un muro. E dietro questo muro si trovano lo stesso Militina, Lulù e tutti compagni di lavoro. Potrebbe essere il paradiso, ma tutto rimane malinconicamente avvolto da una fitta nebbia.
Resta il fatto che l’unione dei lavoratori aveva prodotto un risultato, seppure piccolo, mentre sul fronte sindacale tutto tendeva a stagnare e a impantanarsi su compromessi da valutare, volta per volta, col bilancino.
Oggi, a distanza di 40 anni, le vicende attuali riportano alla ribalta il tema del lavoro impossibile. Certamente la divisione in classi della società è mutata. Operaio è chiunque, ogni giorno, deve fare quadrare i conti con un mercato del lavoro che non offre alcune prospettive. Padrone è colui che detiene le leve del potere politico ed economico. Il diritto alla felicità è costretto nell’ottenimento di un lavoro che c’è o non c’è. Le esigenze del mantenimento della produzione e il pericolo di fuga dei capitali verso paesi che offrono prestazioni lavorative a basso costo mettono paura, non solo ai cittadini, ma anche a una classe dirigente della politica che non sa più cavare un ragno dal buco.
 Si vira verso una società che formerà individui programmati all’esecuzione di lavori specifici. Non ci sarà posto per lo studio delle materie umanistiche, che non sono utili all’inserimento nella catena di montaggio di una società che lavora a ogni costo, ma senza sapere neanche perché o per chi.
Si vira verso una società che formerà individui programmati all’esecuzione di lavori specifici. Non ci sarà posto per lo studio delle materie umanistiche, che non sono utili all’inserimento nella catena di montaggio di una società che lavora a ogni costo, ma senza sapere neanche perché o per chi.
Il compagno Militina ricordava a Lulù di avere cominciato ad accusare i primi segni di follia quando si era chiesto a che cosa servisse il suo lavoro: « Pensa che io un giorno incontrai l’ingegnere, lo presi per il collo e gli dissi: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Perché un uomo ha il diritto a sapere a che cosa serve il suo lavoro. Il denaro: comincia tutto da lì. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi. Noi diventiamo matti perché ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ne hanno troppi. E così, in questo inferno di pianeta, pieno di ospedali, cimiteri, fabbriche, caserme, il cervello a poco a poco se ne scappa, sciopera».
Dice Dostoevskij in Memorie di una casa morta: «Una volta mi venne in mente da pensare che, se si fosse voluto totalmente schiacciare, annientare un uomo, punirlo col castigo più orrendo, tanto che il suo più efferato assassino dovesse tremarne e anticipatamente averne spavento, sarebbe bastato soltanto conferire al lavoro il carattere di una perfetta, assoluta inutilità e assurdità».
Diceva John Adams: «Io devo studiare politica e guerra perché i miei figli possano avere la libertà di studiare matematica e filosofia, geografia, storia naturale e architettura navale, navigazione, commercio e agricoltura per dare ai loro figli il diritto di studiare pittura, poesia, musica, architettura, scultura, l’arte dell’arazzo e della porcellana».
La politica economica di uno stato dovrebbe livellare, indirizzare, ridistribuire, per costruire una società che progredisca in modo omogeneo. Qui non si tratta di comunismo, non si vuole abolire la proprietà privata, non si vuole cancellare – se mai è esistita – la meritocrazia. Quando pochi alberi svettano sugli altri, si taglia la cima per dare un po’ di luce a quelli che stanno sotto.
 Prima e durante i fenomeni totalitari, i corpi venivano riuniti e fatti marciare in colonne, come il bestiame, esattamente come l’immagine degli operai del film che, accompagnati dalla marcia militare della colonna sonora di Morricone, entrano in fabbrica per un nuovo turno di lavoro. Adesso, le coscienze di quei corpi sono inglobate in spazi comunicativi nei quali la concentrazione fisica è sostituita dalla distrazione mediatica. La politica sembra dormire, il paradiso dei nuovi poveri invece può attendere.
Prima e durante i fenomeni totalitari, i corpi venivano riuniti e fatti marciare in colonne, come il bestiame, esattamente come l’immagine degli operai del film che, accompagnati dalla marcia militare della colonna sonora di Morricone, entrano in fabbrica per un nuovo turno di lavoro. Adesso, le coscienze di quei corpi sono inglobate in spazi comunicativi nei quali la concentrazione fisica è sostituita dalla distrazione mediatica. La politica sembra dormire, il paradiso dei nuovi poveri invece può attendere.
Lo chiamavano cinema dell’impegno civile. Ma era tanto tempo fa. Molti anni prima di questo grande sonno collettivo.
Si ringrazia per l’editing M. Laura Villani
Clicca qui se vuoi ascoltare la marcia dei lavoratori
Clicca qui se vuoi ascoltare cosa dice il vecchio Militina
Clicca qui se vuoi vedere come andrà a finire
Clicca qui se vuoi conoscere il programma degli investimenti
Clicca su mi piace se vuoi essere informato su ogni iniziativa de Il dolce inganno
- Skyfall, quando il cielo cade - 12 Novembre 2012
- Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, l’immagine del potere non può essere scalfita neanche di fronte all’evidenza - 21 Maggio 2012
- The Help e l’Oscar al femminile che forse non verrà - 20 Febbraio 2012




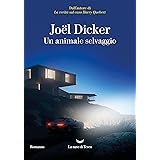

Carla, Raffaele, sono d’accordo. Gli artisti devono anche tenere conto del gradimento del pubblico, ma ormai si progetta l’arte sulla base delle proiezioni di vendita.
Un vero peccato.
Grazie per i vostri interventi.
Quelli come me che hanno superato da poco i 20 anni(!) ricordano di certo le serate passate a discutere ai cineforum del comune o dell’oratorio.
Noi ragazzi che non lavoravamo in fabbrica, discutevamo di lavoro, di diritti dopo aver visto film come questo e tornavamo a casa stanchi, ma più ricchi. Al mattino, sul pulmann che ci portava a scuola o all’università le discussioni riprendevano e c’era sempre qualcuno che nella notte aveva cercato su libri qualche elemento in più per capire meglio.
oggi c’è Zalone che, seppur bravo e simpatco, mi fa dire che l’arte e l’impegno se ne sono andati lontani dal nostro paese.
ed un filmetto come quello di Checco Zalone fa il record di incasso
un bravo cabarettista e nulla più