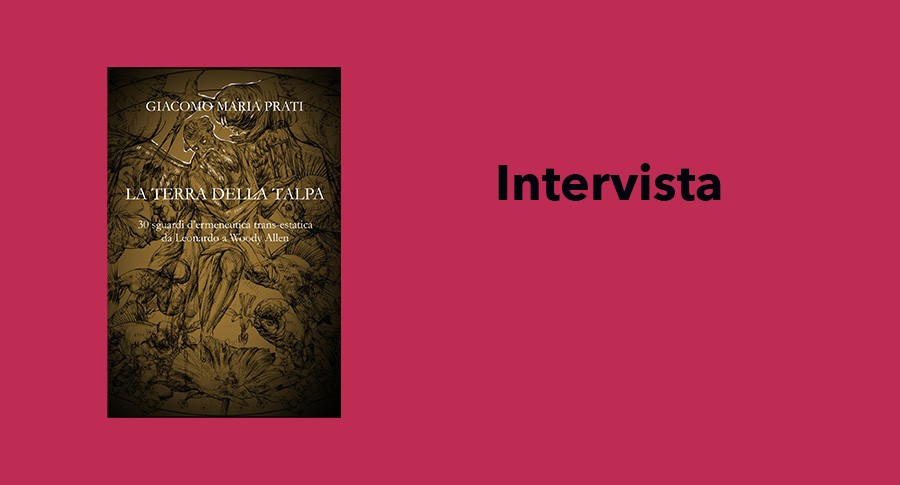Intervista di Marco Candida a Giacomo Maria Prati
Recentemente è uscito il ventiquattresimo saggio di Giacomo Maria Prati, La terra della talpa. 30 sguardi d’ermeneutica trans-estatica. Da Leonardo a Woody Allen. Può essere utile ragionare sulla saggistica quale modello autonomo rispetto ai propri temi e quale paradigma conoscitivo ed euristico. La produzione feconda e intensa di questo autore ci può aiutare quindi a riflettere sulla saggistica indipendentemente dalla definizione delle tematiche specificamente trattate. Uno dei suoi tratti appare infatti la declinazione iper-focalizzante di argomenti già noti e ampi oppure al contrario la tipizzazione tendente all’universale a partire da approfondimenti di nicchia. Oggi l’ermeneutica quale “arte dell’interpretazione” appare un’esigenza sempre più urgente e necessaria, favorita anche dall’emergere di punti di vista molteplici e differenziali, come dimostra ad esempio il caso della geopolitica, oggi tema di moda ma fino a pochi anni fa appannaggio riservato di pochissimi addetti ai lavori.
Caro Giacomo, perché questo tuo nuovo libro e in cosa si distingue dalle altre due raccolte di saggi che hai editato nel passato: Mitogonia e Il ritorno di Hermes. L’ermeneutica come mito?
Da un certo punto di vista siamo in continuità con le altre raccolte, dall’altra si tratta di una raccolta più consapevole e più sistematica in quanto articolata in sette sezioni connotate da ampi temi che a loro volta vogliono porsi come griglie ermeneutiche. Una sezione è dedicata ad esempio a Leonardo e Pinocchio, ed è incentrata sul tema della trasformazione. L’opera cresce gradualmente in intensità e profondità e si conclude con la definizione dell’anima gnostica di Nanni Moretti e con un pezzo sul rapporto fra nulla, il respiro e Dio. La talpa è chi non si accontenta di scavare in superficie, come fanno le galline per le loro sabbiature ma ama vivere in un buio illuminato dal desiderio della ricerca. La terra che la talpa scava la eleva al di fuori. Si crea così una corrispondenza tra gli opposti: il vuoto dei suoi cunicoli e le collinette che rivelano la sua silente presenza dinamica. Mi sembra la talpa una buona immagine per chi ha il gusto ossessivo dell’interpretazione, dell’analisi e della meditazione. Chi è più costruttiva di una talpa? Chi abita la propria materia meglio di una talpa? Eppure distrugge, scavando, ma lo fa rispettando la natura reattiva del terreno.
Perché nel sottotitolo parli di “ermeneutica trans-estatica”? Cosa intendi precisamente?
Per “estasi” intendo il senso etimologico e letterale del termine greco quale: “farsi possedere” da qualcosa che è altro da noi, e più di noi. Penso che ogni passione e quindi anche quelle mentali, conoscitive, abbiano come loro radice una forma di possessione. Facciamo spazio ad altro e ad altri e ci mettiamo in un angolo, per andare oltre noi stessi e fuori dal nostro ridotto ego. Così possiamo immergerci in ciò che ci piace così tanto da farci perdere i confini della nostra individualità. Ma non basta. Se vogliamo scendere nel profondo e nel contempo essere condivisibili, attrattivi e partecipativi occorre che la nostra “arte dell’interpretare” sia anche trans-estatica, cioè non solo passionale e ossessiva ma sappia pure darsi un metodo, una forma, una lingua. “Trans” pure nel senso di “attraverso”, cioè attraversare come in un viaggio la materia in cui si è immersi amplessivamente. Si dice che ad Aleppo, in Siria, Tamerlano abbia fatto erigere, usando le teste mozzate di 20.000 cittadini, torri alte 5 metri.
Ritieni che Carmelo Bene si sia concentrato su Tamerlano perché questa leggenda delle teste mozzate in fondo faccia riferimento in modo macabro alle maschere pirandelliane del teatro?
È una bella intuizione. Penso che Carmelo abbia amato tutte le figure estreme della non-Storia che lui rifiutava. Tamerlano nella sua fatalità enigmatica e nel suo poter essere riletto quale oltre-uomo ante litteram non poteva che essere valorizzato e ulteriormente estremizzato da Carmelo Bene. Un uomo-proiettile, senza un’ideologia. Potere puro, vuoto, cosmico, quindi implicitamente veicolante l’essenza greco-nichilistica del tragico.
Il sottotitolo del tuo fantastico saggio cita esplicitamente Woody Allen. Ora, mi sono rivisto ultimamente un po’ di teatro alternandolo alla visione di alcuni film di Woody Allen. Ritieni davvero che Woody Allen sia all’altezza di Shakespeare, Bertolt Brecht, Bernard Shaw…?
Sì, nel senso beniano di incarnazione del mito di Narciso quale tragedia e non commedia e, anche, in senso stirneriano. Woody Allen è l’essenza concentrata e acida dello spirito borghese nel suo capolinea nichilista. Non possiamo quindi non illuminarlo con Carmelo Bene e viceversa. Lo stesso regista statunitense ha giustamente sempre rivendicato la propria natura tragica e teatrale che emerge con forza in opere come Blu Jasmine, Settembre, e Match Point ma è sottesa in quasi tutte le sue opere.
Da dove ti viene tutta questa fantasia ermeneutica? Dove la peschi?
Dopo molti anni di letture, sogni ad occhi aperti e ascolti contemplativi evidentemente qualcosa si è acceso e si è irradiato in me. Ho scoperto istintivamente una sorta di metodo dentro le mie molte curiosità e passioni intellettuali. Ho cercato dei nodi, degli incroci dove passassero più linee semantiche e narrative, alla ricerca dell’intensificazione e di uno sguardo panottico. Grandi scuole ermeneutiche sono state le Sacre Scritture, la filosofia del diritto secondo l’opera di Amedeo Conte dell’Università di Pavia e la conversazione con mio padre su temi filosofici e letterari.
Ho trovato interessante il tuo omaggio a Francesco Nuti nel saggio intitolato “Il puer beniano”. Nuti o Pieraccioni? Nuti o Panariello? Nuti o…
Nuti, ovvero il “puer” di James Hilmann. Ma in Nuti c’è anche qualcosa di enigmatico, silente, latente che, penso, appartenga ai carismi più autentici dell’“essere toscano”, come già alluse Curzio Malaparte in Maledetti Toscani e lo stesso esoterista Elémire Zolla riguardo ai tratti isiaci e cibelici del mito di Pinocchio e di Pinocchio come Mito. Peccato che ad un certo punto volle imitare i format statunitensi, perdendo la sua anima, come dimostra il fallimento colossale di OcchioPinocchio.
Nella sezione “Ars gratia artis” del tuo saggio l’ultimo capitolo tratta di Heidegger e della “critica alla critica”. Ritieni che oggi ci sia ancora bisogno di critica? Ritieni che sia possibile una critica? Una critica che non esalti la mediocrità a detrimento del vero valore?
Anche in questo seguo Carmelo Bene, che a sua volta seguiva Deleuze: non c’è critica senza creatività e non c’è creatività senza critica. La mia ermeneutica immersiva e anagogica tende all’incandescenza autoriale fino a perdere e a far perdere i confini fra interprete e interpretato.
Il tuo accostamento tra Achille e Alessandro Magno e tra Pascoli e Carmelo Bene mi fa venire in mente scrittori e poeti quali Giuseppe Ungaretti e Primo Levi. Mi chiedo se esista una reale differenza tra reduce da una guerra ed eroe di guerra. E anche tra reduce da una guerra, eroe di guerra e scemo di guerra.
Bell’accostamento, acuto. Dal punto di vista di Achille e di Pascoli/Ungaretti siamo tutti inattuali, siamo tutti reduci. Parlo per chi abbia quel minimo di coscienza viva e sveglia, nella notte. Non esiste un tempo al di fuori della struttura, debole, della nostra individualità. Quale lancio e quale decisione è la freccia della nostra esistenza? La vita per Pindaro era l’ombra di un sogno nella quale ogni tanto balenava all’improvviso qualche splendore. Compito del poeta e dell’artista è captare questi bagliori, e provare a trattenerli e a prolungarne la risonanza.
Quali altri libri, speriamo ricchi come questo, hai in cantiere?
Spero nessuno, se non la seconda parte della Terra della Talpa che si chiamerà Saturno e l’Orchidea. Non si poteva far uscire tutto subito, insieme, per l’eccesso di pagine. Attualmente sto scrivendo un saggio spirituale sul tema, centrale, della Croce quale fondamento del Cristianesimo. Spero di poter portare a termine questa non facile impresa, che ritengo di grande importanza e attualità in un tempo in cui si sta perdendo il senso della via cristiana. Avevo scritto il mio saggio sul Nulla per liberarmi dalla mania dello scrivere ma quale tema migliore della “Croce” per voler concludere quel percorso di studio, ricerca e meditazione che ho iniziato nel 2012.
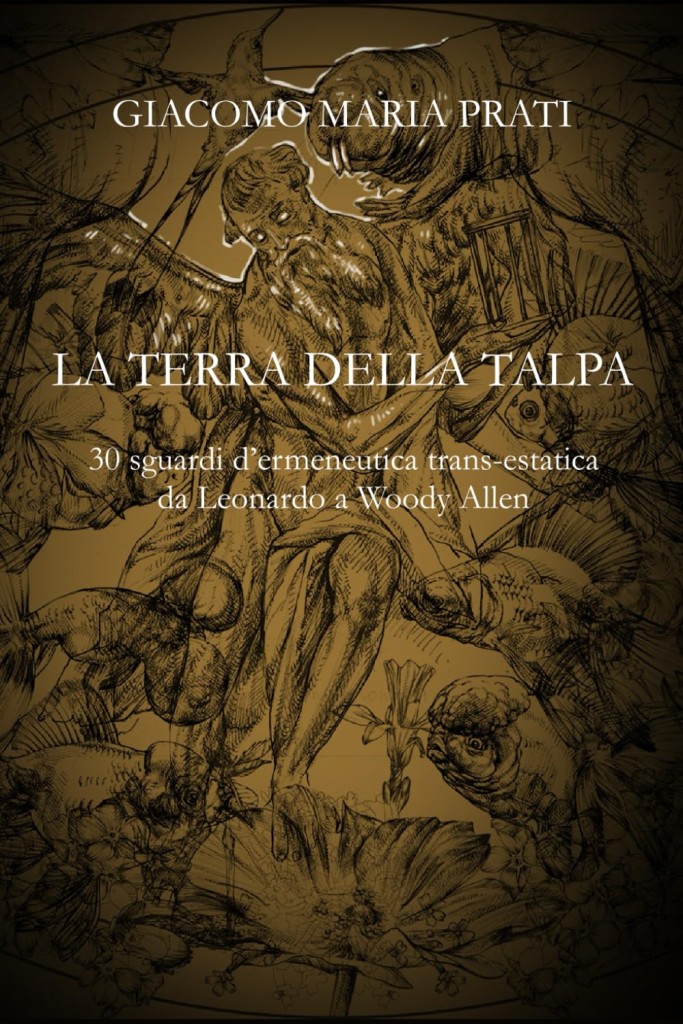
Giacomo Maria Prati, La terra della talpa
Editore: Independently published
Data di pubblicazione: 28 aprile 2025
Lingua: Italiano
Lunghezza stampa: 340 pagine
ISBN-13: 979-8281718943
- La terra della talpa - 20 Maggio 2025
- Parlarsi è uccidersi - 27 Marzo 2025
- Ladri di tempo [recensione] - 26 Marzo 2025