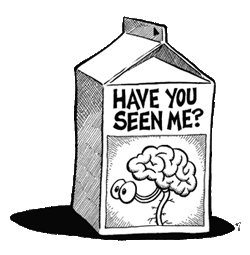di Enzo Buscemi
Ero a Milano da qualche mese. Spostamento provvisorio e pendolarismo da Roma. Ogni quindici giorni, o giù di lì.
Mi ero sistemato in un piccolo albergo, dalle parti di corso Buenos Aires, finché avevo accettato la proposta di un collega (corrispondente da Milano di un noto e, molto chiacchierato, settimanale politico romano), che mi aveva ospitato nella seconda camera da letto del suo appartamento.
Ricambiavo la cortesia pensando quasi sempre al vettovagliamento, con conseguente ‘dominio’ della cucina.
L’elettrotecnico
Con Pino ci conoscevamo da anni.
Anche se, per carattere, eravamo praticamente agli opposti, ci accumunava la uguale passione per l’abbigliamento elegante, le belle automobili e il sesso gentile. Una buona accoppiata ma con motivazioni assolutamente diverse.
Molto complesso, tormentato e spesso aggressivo lui.
Io, in ugual ragione, scanzonato e, in apparenza, teneramente timido.
Le due polarità funzionavano a meraviglia, e la convivenza era praticamente perfetta.
Gestivamo le eventuali relazioni in modo da non darci fastidio e regolavamo orari, ‘arrivi e partenze’, con la massima discrezione.
In comune, però, avevamo rimediato un curioso optional.
Al piano di sotto abitava Marisa (nome di fantasia) giovane e sofisticata, proprietaria di un negozio d’antiquariato nei pressi di via Broletto.
Ci eravamo conosciuti nella trattoria toscana, di corso Garibaldi, che frequentavamo regolarmente. Marisa era decisamente molto spigliata. Così, dalla scoperta della simpatica coincidenza di indirizzo, era nata una piacevole consuetudine.
Quando capitava che, certe sere, io e Pino rimanessimo a casa, bastava battere qualche colpo di tacco sul pavimento e, puntualmente dopo pochi minuti, Marisa bussava alla porta. L’abbigliamento era sempre lo stesso, una morbida pelliccia.
Indossata sul niente.
Così, tutti e tre, passavamo, piacevolmente, molte delle nostre serate. E senza alcun contrasto.
Certi gusti, con Pino, erano quindi in comune. Le differenze erano limitate alla specializzazione del lavoro.
Torniamo all’antefatto. Dopo l’uscita, piuttosto movimentata, da un popolare settimanale automobilistico, avevo scelto di non riaccasarmi. Almeno per qualche tempo. E fare, come usa dire nel nostro gergo, il battitore libero. Traduzione romanesca del tradizionale ‘free lance’. In parole povere: ‘scriverò per chi mi piace, quando e come mi andrà a genio’.
Così, avevo deciso di tornare a Milano dove, qualche anno prima, era avvenuto il mio battesimo del fuoco.
Ai quattro quotidiani del sud, con i quali da anni collaboravo per le le pagine dei motori e dello spettacolo, avevo aggiunto immediatamente due ottime testate. Il più moderno e disinvolto dei quattro più importanti quotidiani milanesi e il famoso settimanale femminile del quale, parecchi anni prima, ero stato caporedattore di un mitico Direttore.
Per il quotidiano confezionavo un’inchiesta dopo l’altra. Del genere pepato, in ossequio alla mia innata passione per la cronaca. Decisamente implacabile. Al punto che, certi colleghi, mi identificavano con una poco amata bestia feroce.
Intendiamoci, l’equiparazione a quel povero animale che, per tradizione, non gode di molta simpatia, era nata non tanto dal fatto che mi sarei nutrito di cadaveri, quanto dall’inseguimento della notizia, costi quel che costi. Perciò, contrabbando, malcostume, vita notturna e molto altro ancora, erano oltre che il mio ‘cibo’, la soddisfazione del capo cronista di turno.
Tutt’altra musica per il settimanale. Interviste alla famosa chansonnier, al genio del teatro, al grande sarto e, se capitava, anche qualche inchiesta, con tocco delicato s’intende, sulla sessualità delle giovanissime o sulle molestie (oggi stalking) nel mondo della moda e del cinema. Con grande disinvoltura, passavo da un estremo e da uno stile all’altro. E, come sempre, mi divertivo.
Con me, a Milano, era arrivata la mia protesi del momento. Una Dino spider, blu Francia, che tenevo in un garage poco distante dalla nuova abitazione. La usavo per le frequenti gite verso i laghi. Per tornare a Roma, invece, e rimanerci solo un paio di giorni, spesso sceglievo il vagone letto. Meno faticoso e senza il problema nebbia, che ancora mi terrorizza.
Così andava da parecchi mesi, ed eravamo arrivati al nuovo anno. Negli ultimi giorni di gennaio decisi che avrei fatto una delle solite scappate nella capitale. Il mio coinquilino era appena rientrato da un soggiorno, segretissimo, in Francia. Ci era andato portando con sé uno strano personaggio. Un aspirante terrorista di estrema destra che, alla famosa giornalista di un grande settimanale (notoriamente, invece, orientato a sinistra), aveva appena raccontato di certi campi paramilitari, dove si addestravano gli estremisti in odore di attentati.
L’articolo aveva suscitato clamorose reazioni, ma il periodico (nel quale militava il mio collega), di segno politico diametralmente opposto, e con un’offerta ancora più generosa, aveva convinto il ‘terrorista’ a vestirsi da pentito, a ritrattare ogni parola di quell’intervista, e a cedere un corposo dossier relativo ai deprecati campi. Documenti che finirono, immediatamente, nella cassaforte del settimanale, per cancellare ogni eventuale prova della prima incauta intervista.
Per evitare che il discusso personaggio ritrattasse nuovamente, cedendo alle eventuali offerte di altri giornali, lo affidarono a Pino perché lo portasse lontano da pericolose tentazioni. Perciò il soggiorno in Francia e, infine, il rientro in Italia, molto ben retribuito, del testimone e la sicura custodia del sostanzioso, segretissimo, dossier.
Pino mi aveva raccontato tutto.
La nuova intervista ‘chiarificatrice’ era stata pubblicata e l’eco era ancora viva. Lui, appena rientrato da Parigi, era stato inviato a Sanremo, a seguire il Festival della canzone.
Questo, per quanto ne sapevo, era stato l’inizio. Quella sera avevo appena consegnato al caporedattore del quotidiano un reportage su una “Notte romana a bordo di una Pantera”, della Polizia, s’intende. Lo avevamo riletto insieme, scelto le foto e organizzato l’impaginazione con l’art director. Erano appena passate le 20 ed ero pronto per Roma.
Avevo prenotato il letto, sul rapido delle 23,30. Non mi restava che andare a casa, mangiare qualcosa, chiudere il borsone e filare in Centrale. Un tassì mi portò velocemente in via Giusti.
Il nostro appartamento era al superattico. Certamente risultato miracoloso di qualche generoso condono edilizio.
Sorgeva nel lato sinistro della sterminata terrazza. In uno splendido isolamento dal resto del condominio, ed era strutturato come elegante loft.
Ci si arrivava, di sicuro, anche dall’appendice delle scale che, però, non avevo mai visto.
Con Pino usavamo esclusivamente l’ascensore che emergeva da un gabbiotto, vicino alla porta d’ingresso dell’appartamento. Comunque, a parte il problema dei pochi metri da percorrere all’aperto, fino al portoncino, l’accesso all’alloggio era agevole.
Uscii dall’ascensore, qualche passo, infilai la chiave nella toppa ed entrai nel grande ingresso. Dall’interruttore, sulla destra accanto alla porta, accesi le due appliques sulle opposte pareti.
“Da dove arriva questo vento freddo” mi chiesi, forse ad alta voce, notando qualcosa di insolito. “Ah ecco”.
Avevo infatti notato la tenda di uno dei due balconi sul lato sinistro della stanza, gonfia e ondeggiante. Pensai di aver dimenticato di chiudere la parte superiore, mobile, dell’imposta, e mi avviai a girarne la manovella di comando.
Feci scorrere le tende.
Dietro i vetri del balcone, un viso barbuto mi fissava con occhi spiritati. Indossava un eskimo chiuso fino al collo e, a corollario, una grossa pistola puntata all’altezza del mio viso.
“Porca puttana”, e istintivamente feci scorrere la cinghia della tapparella che, ahimè, si bloccò a mezza altezza. Mi venne in mente, con terrore, che da giorni era da riparare. Così, la pistola rimase in bella vista.
“Fammi entrare, ridammi i documenti o ti sparo”, urlava il tale da dietro le robuste imposte che ancora non era riuscito a forzare.
“Aprimi stronzo o ti sparo”, ripeté ancora. Hai un bel dire, “Se capita a me gli do un calcio nelle palle e, quando cade, gli do un altro calcio, gli monto sulla schiena e telefono alla polizia”.
Il tutto va ridimensionato. Lo racconto adesso, ma è accaduto alla fine degli Anni ’60. I cellulari non li avevano ancora inventati. E il telefono, con tanto di disco numerico, in quell’appartamento, stava su un tavolo, drammaticamente di fronte al tizio con la pistola.
Ricordo che scappai urlando e mi tirai dietro la porta, facendola sbattere con grande rumore. Partii di gran corsa verso il gabbiotto dell’ascensore. Schiacciai il pulsante: “Occupato”. Cazzo. Continuai freneticamente a insistere sulla chiamata. Mi girai a guardare verso l’ingresso e scoprii (si fa per dire, perché lo sapevo già), con una dose supplementare di sconforto, che il balcone a filo del muro esterno e il suo ospite minaccioso, erano ancora, pericolosamente, a pochi metri da me.
Mi appoggiai alle porte dell’ascensore cercando inutilmente di dissimularmi con il sottile bordo in muratura. E, se non bastasse, ero, crudelmente, illuminato da una malvagia lampada al neon, che splendeva sull’architrave.
“Sono un bersaglio facile. E se quello rifà il percorso dell’andata, in equilibrio sul cornicione, mi raggiunge e mi spara?”
In quel momento, chissà perché, non pensai che dalla parte opposta della terrazza c’erano le scale. Ma non le avevo mai usate. Non sapevo dove fossero esattamente, e temevo che se fossi uscito allo scoperto, lo sconosciuto mi avrebbe, probabilmente, sparato.
Fidai sull’arrivo dell’ascensore. Il tale, dal balcone farfugliava qualcosa in un dialetto, forse pugliese, mi sembrò. Ma non lo capivo, e non mi posi il problema. Mi costrinsi, invece, a recuperare un minimo di freddezza. Le agognate porte finalmente si aprirono.
Dito sullo ‘Zero’ e vai!
Uscii correndo su via Giusti e irruppi nella trattoria toscana dove spesso con Pino andavamo a cenare. “Fulvio, il telefono per favore”. Senza attendere risposta dal proprietario, usai l’apparecchio, accanto al registratore di cassa. Composi il 113. Risposero immediatamente.
“Sono un giornalista, ho trovato un uomo armato in casa. Via Giusti, N°…, di fronte alla trattoria toscana. Vi aspetto”.
Ringraziai l’oste. Ero appena tornato sul marciapiedi, che la verde, cara ‘Giulia’, arrivò con tanto di sirena.
Altri tempi. Un lampo. Erano in due coi giacconi di pelle d’ordinanza.
Un agente sui cinquanta, piuttosto pesante e l’altro giovanissimo che guidava.
Gli spiegai l’accaduto.
“Tu va’ per le scale. Noi saliamo con l’ascensore e attento mi raccomando. Potresti incontrarlo che scende”, disse al suo collega il robusto capo pattuglia.
In terrazza aspettammo, nell’ascensore, che il giovane poliziotto emergesse dal buio. Indicai agli agenti il balcone. L’ospite era ancora lì. Evidentemente gli era mancato il coraggio di riaffrontare il sottile cornicione.
Raggiungemmo la porta ma spostandoci velocemente all’estrema destra del fabbricato, per sottrarci alla vista dell’intruso. Entrammo.
“Lei stia indietro” mi ammonì l’agente anziano. Poi tutti e due si addossarono al muro, accanto al balcone.
“Amico, adesso apriamo le imposte, metti la pistola per terra e alza le mani” disse con voce tonante il poliziotto anziano “Non vogliamo farti del male. Ma siamo in due e, se occorre, spariamo bene. Dimmi se hai capito. Alzeremo la tapparella per vedere se sei stato bravo, e poi ti aprirò. Okey?”
Il capo fece un cenno al giovane collega che senza mettersi davanti al balcone allungò un braccio e tirò la cinghia della serranda che, miracolosamente, si alzò.
“Pistola a terra e mani in alto” disse l’agente, questa volta con voce conciliante, e mi guardò chiedendo conferma, perché il mio punto di vista era ovviamente privilegiato. Vidi che lo sconosciuto aveva eseguito. “Va bene”, gli dissi a bassa voce. Lui sporse la testa e si accertò. Rapidamente gli agenti aprirono le imposte, presero l’uomo per le braccia spingendolo in mezzo alla stanza e lo ammanettarono.
Lo osservai. Finalmente senza timore. Sulla trentina, capelli nerissimi e non certo curati, come la barba, si inanellavano sul collo dell’eskimo protetto dall’imbottitura, non proprio linda, del cappuccio ripiegato. Le gambe inguainate in pantaloni di velluto, una volta marrone, finivano in anfibi militari stranamente puliti. L’espressione dello sconosciuto era cambiata. Sembrava tranquillo, come si trovasse tra amici.
Il poliziotto calzò i guanti neri dell’uniforme, raccattò la pistola, ne sfilò il caricatore e la ripose in una tasca del giaccone.
“Sta buono e non ti succederà nulla. Hai un documento?” chiese il poliziotto anziano.
“Si” disse l’uomo e accennò un movimento con le mani bloccate dalle manette.
“Sta fermo, lo prendo io”, replicò l’agente giovane, “dove lo tieni?”
“Nella tasca posteriore dei pantaloni”. Venne alla luce un vecchio portafogli, nero e sdrucito. L’agente lo consegnò al capo che ne estrasse un variegato contenuto che dispose sul tavolo. Tra carte varie c’era quella d’identità.
La esaminò con calma: “Come ti chiami?”
“Antonio P.” replicò l’interessato e mi venne, subito, da ridere. Il cognome era lo stesso dello sfortunato protagonista di un film di Nanni Loy.
“Che lavoro fai?” chiese ancora l’agente.
“Sono un estremista” si qualificò l’uomo con evidente sussiego. Quasi orgoglioso di quella particolarissima, esclusiva, specialità.
Il corpulento poliziotto avvicinò la carta d’identità a un’applique, la riconsultò con attenzione ed esordì: “Allora, perché qui c’è scritto elettrotecnico?”
Non riuscii a trattenermi dal ridere. ‘Uno a zero per i Carabinieri’. Per giustificarmi, dissi la prima cosa stupida che mi venne in mente: “Ma guarda che coraggio!”
“Estremista o elettrotecnico adesso vieni con noi in Questura. E anche lei dottore”.
“Ma alle 23,30 ho un letto prenotato per Roma”.
“Mi spiace, deve firmare la denuncia per violazione di domicilio”.
“Io sono soltanto un ospite. Titolare è un mio collega che adesso è a Sanremo”, tentai, inutilmente, per salvarmi.
“Venga in macchina con noi. Farà sicuramente in tempo a prendere il treno. Si porti la valigia”.
Presi il borsone, chiusi le imposte e la porta e ci avviammo.
Alla Questura centrale mi fecero entrare in una stanza dove l’arredamento era limitato a due sedie, un tavolo e una decrepita macchina per scrivere.
“Attenda, verrà il commissario”.
E chiusero la porta che, all’interno, non aveva alcuna maniglia. Viva la fiducia.
Dopo una decina di minuti arrivò un signore che si presentò come Natoli, commissario di turno.
“Buonasera dottore, purtroppo debbo farla attendere”, si giustificò, “Vuole vederla il dottor Altieri. Non la farà aspettare molto. Nel frattempo, arriverà un agente per il verbale”.
Mi arrivò il brivido da manuale. Il dottor Altieri era il temuto capo della ‘Politica’. Più nota come Digos.
Il poliziotto annunciato, arrivò. Laboriosamente compilò un verbale dove le complicazioni si succedevano senza pietà.
“Come mai stava in quell’appartamento senza il legittimo intestatario? Ma non è residente a Milano? E come ha conosciuto il fermato A. P.?” E così via per una stesura interminabile. Rilessi, e dovetti farmi forza per non ‘passare’ il testo ‘costellato’ di perle deliziose. Comunque lo firmai. Tornò il commissario di prima.
“Ma il suo amico esiste veramente?” insinuò celandosi dietro un sorriso ipocrita.
Di nuovo gli spiegai che era al Festival. Gli dissi in quale hotel alloggiasse e, se voleva trovarlo, chiamando la sala stampa dell’Ariston glielo avrebbero passato.
“L’Ariston?”
“È il teatro dove sta svolgendosi il Festival. Il numero telefonico non lo conosco. Ma se il suo centralinista chiamerà la questura di Sanremo avrà quello che le serve. Caro commissario, ho firmato il verbale specificando che sono ospite del mio collega, che ho trovato l’intruso, che non so chi sia, e vi ho subito chiamato. Sono quasi le 22 ho un letto che mi attende sul rapido delle 23,30 per Roma. Ormai non le servo più, posso andare?”
“Vede caro dottore”, replicò con affettata gentilezza il commissario, “Noi conosciamo bene quel tale che era in casa sua. Per questo la vuole vedere il dottor Altieri. Era a casa, sta arrivando. Quindi deve avere pazienza”.
“Gentile commissario, so che il dottor Altieri è il capo della Politica, e mi rendo conto che sappiate chi sia quel personaggio. Mentre io non ho la più pallida idea di chi possa essere. E certo non scappo, lavoro al Giorno, telefoniamo al caporedattore, se vuole. Due ore fa gli ho consegnato un articolo. Uscirà domani su una intera pagina. Racconta di una notte su una delle vostre Pantere in giro per Roma. Se fossi un delinquente non andrei a lavorare con la Polizia”. Ero esausto.
“Vado e torno”. E uscì.
Stavo decisamente crollando. Non sapevo più a che diavolo votarmi. Bloccato come un delinquente. Ma proprio a me?
Stavo affannosamente rimuginando su qualcosa da inventare, per riguadagnarmi la libertà, quando la porta si aprì e fece capolino un viso conosciuto. Meraviglia.
“Che cazzo ci fai nella stanza degli interrogatori?”
“Giacomo aiutami” urlai senza rendermene conto. Era Zatteri, il capo della Giudiziaria del famoso quotidiano. Lo conoscevo da tempo. Un simpatico, ma soprattutto di ‘casa’ in Questura centrale. Gli spiegai brevemente.
“Allora eri tu. Ero venuto a vedere. Mi hanno detto che avevano arrestato un estremista nero e che c’era un giornalista romano in posizione poco chiara. Per questo hanno chiamato il capo della Politica. E che cazzo, sono furbissimi. Vieni con me”.
“Giacomo vedi che non c’è la maniglia. Non vorrei che mi arrestassero per evasione. E addio treno per Roma”.
Giacomo rise di gusto, mi prese sottobraccio.
“Porta la valigia, vedrai che andremo via. Ti accompagnerò alla stazione”.
Percorremmo un lungo corridoio fino a un ufficio ben arredato, inconsueto per quel luogo. Un funzionario, elegante come il suo ambiente, e subito molto cordiale, si alzò venendoci incontro, ma non si presentò.
Giacomo gli spiegò che ‘il complice dell’estremista’ ero io e mi chiese di riassumergli la vicenda.
“Non serve. Ho letto il verbale ed ho già contattato Sanremo. Stanno cercando il suo amico” replicò subito il misterioso funzionario, “Ma lei certo sapeva della vicenda dell’estremista che ha preso i soldi da due giornali concorrenti. Non credo che il suo amico non le abbia detto nulla”.
“So quanto è stato pubblicato e qualche aneddoto”, mentii, “Il mio collega è molto riservato. Abbiamo stipulato un sacro patto dell’ospitalità: che ognuno si faccia gli affari propri. E poi caro dottore, visto come sta andando la faccenda se, ingenuamente, avessi ammesso di sapere qualcosa, non crede che sarei già a San Vittore. Ma adesso, mi farebbe andare a Roma?”
“Ma certo. Si accomodi. Quando tornerà a Milano venga con Giacomo, faremo modificare quel verbale nel senso che merita, e poi andremo a cena alla ‘Torre di Pisa’, a Brera, un posto simpatico”.
“Ne sarò lieto, la ringrazio molto”.
“E l’elettrotecnico?”
“Prego?”
“Come non detto. Grazie ancora, dottore. Buonanotte”.
Copyright Enzo Buscemi, 2019.
- La quale… [parte II] - 26 Maggio 2025
- La quale… [parte I] - 26 Maggio 2025
- La terra della talpa - 20 Maggio 2025