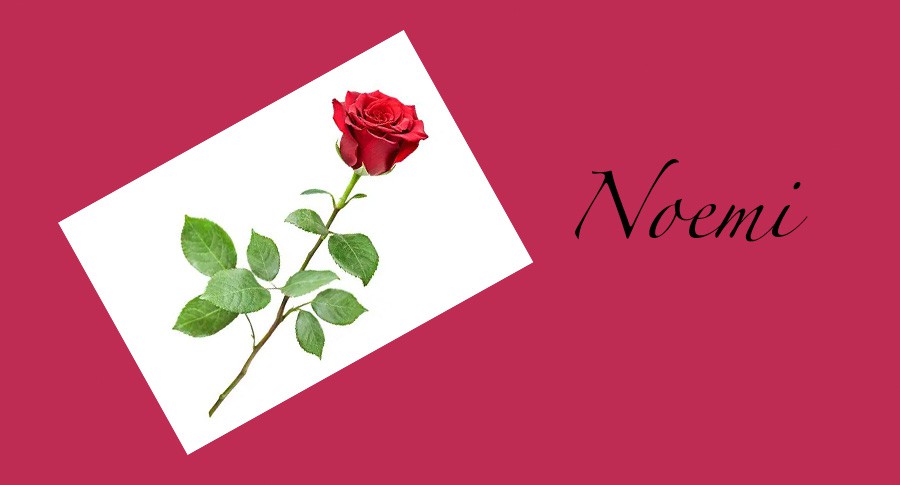di Enzo Buscemi
Quando il sonno stenta a farsi accettare, o si interrompe innanzi tempo, le notti diventano smisurate. E si popolano di un turbine di ricordi.
Alcuni, se per certi versi felici, soccombono alla violenza di omologhi sciagurati.
Anche quella notte, tornai indietro nel tempo.
A qualcosa che aveva modificato profondamente la mia personalità.
Un accaduto, del quale non avrei mai parlato ad alcuno. Né un amico, né tantomeno un familiare.
Un segreto, rievocato chissà quante volte. E, altrettante, rimandato in fondo all’anima. Con la vana speranza di dissolverlo. Affrancandomi, finalmente, da una sofferenza difficile da spiegare. E, per quegli anni, umiliante e inconfessabile.
…
Cominciò nei giorni del primo liceo.
Le cose, già dall’inizio, non andarono bene. Ma non tanto per me.
Era mia madre a preoccuparsi.
Per il percorso, da casa, all’antico istituto, installato in un ex convento, d’una cittadina limitrofa.
C’erano quasi sette chilometri di una strada tutta curve. Mi divertivo con il mio scooter. Una Vespa, ultimo modello. Possederla, negli Anni 50 per un ragazzo di sedici anni, appena compiuti, era quasi una rarità.
Roba da privilegiati. Altro che automobile che poi, in famiglia, non avevamo più.
Di vetture, negli anni che sarebbero sfociati in quelli del boom, se ne vedevano pochissime. In maggior parte, modelli d’anteguerra. Più o meno raffazzonati, per marciare fino all’ultimo singulto.
Più diffuse le Balilla. Un nome, retaggio del passato regime. Ma, bastava citarne il possesso, per classificarsi nella categoria dei benestanti.
I più ricchi guidavano le Lancia, le rarissime Alfa Romeo o le raffinate Bianchi. Come la nostra. Di mio nonno (che non aveva mai preso la patente) per la verità. Era una S9 beige, con parafanghi verdi, ruote a raggi, dei portafiori ai lati del morbido divano posteriore.
Mi raccontarono del suo esproprio. Negli ultimi mesi di guerra, ad opera dell’Esercito.
Evento quasi unico dalle nostre parti. Ma era andata così.
E fummo costretti a servirci di una Balilla, guidata da Mario, l’autista di famiglia ma, in realtà, da anni solo grande amico.
Erano giorni difficili. La svalutazione aveva minato duramente i capitali. Il commercio riprendeva a fatica.
Noi, per fortuna, non avevamo mai sofferto troppe difficoltà.
La, considerevole, proprietà terriera ci dava abbondantemente da vivere. Quel che avanzava dalle nostre esigenze, veniva quotidianamente portato ai mercati rionali.
Ne restava, ancora, per concedere ai miei genitori e ai miei nonni materni (perché gli altri erano morti, prima che nascessi), di farne omaggio a una vasta cerchia di conoscenti. Specie a quelli più o meno indigenti.
Papà, tornato dal servizio militare, aveva riaperto il suo studio. Ma non erano in molti a chiedergli di progettargli una casetta, e tantomeno una villa. Curava soprattutto le ristrutturazioni di fabbricati danneggiati dai bombardamenti, e le misurazioni di terreni agricoli per cambiamenti di impiego. Molto numerosi in quel periodo.
Poi, con gli anni, il Paese riprese a marciare. Addirittura a correre. All’ansia, subentrarono la tranquillità e la voglia di fare.
…
Ritorno al problema scolastico. Mi iscrissero a quell’antico liceo, di buona tradizione, come gli istituti che avevo frequentato fino a quel momento.
Ci arrivai con un certo timore. L’ambiente era totalmente diverso. Meno raffinato, e molto più rumoroso di quanto altro avessi già frequentato.
Per sentirmi a mio agio, bastarono pochi giorni.
Più o meno quanti ne servirono a mia madre, per entrare in ambasce. Per via del tragitto quotidiano, che avrei dovuto percorrere in scooter.
Mamma era molto dolce. Come mio padre, del resto. Ma quando si metteva in mente qualcosa che secondo lei, serviva a proteggermi, era impossibile non assecondarla.
Capitò, così, anche per la destinazione scolastica.
Nel giro di un mese, fui trasferito cinquanta chilometri più a nord. A un liceo di Messina. Un istituto, ahimè, famoso per la durezza dei suoi docenti.
…
Abitavo a casa dei miei zii prediletti, e dei loro due figli, Giovanni e Sergio, che avrei sempre amato come fratelli.
La frequenza si rivelò subito molto difficile. Non riuscivo a legare con i compagni di classe. Ancora meno, gradivo il distacco, anche arrogante, che mi separava dai docenti.
Fu in quei giorni che, dal mio carattere, emersero aspetti inquietanti.
Solitamente, mi è ancora impossibile accettare qualcuno o qualcosa, che non mi vada a genio. Né, riesco a impedirmi, di rifiutarne i rispettivi corollari.
Nel caso in oggetto, inconsciamente, decisi che non avrei studiato.
E, poiché non avrei potuto spiegare al ‘pubblico’, i motivi della mia rivolta né, da impreparato, apparire come sorta di stupido ignorante, cominciai ad accumulare assenze.
Mi firmavo le giustificazioni, e una volta, mi feci accompagnare da un cocchiere, molto elegante. Tanto che lo spacciai per un mio zio.
Non frequentando, per impiegare il tempo libero, con altri studenti, ugualmente assenteisti, andavo a fare un giro nei Grandi Magazzini. La famosa Upim.
Qualche sorriso alle commesse più giovani e, poco prima delle 10, di corsa in qualcuno dei tre o quattro cinema che, a quell’ora, iniziavano le proiezioni.
Tornavo a scuola solo per i compiti in classe. Specie per quelli di italiano e di greco. O per farmi interrogare in filosofia.
Ignoravo le altre materie e il contenzioso, pericolosamente, aumentava.
…
Uno di quei giorni, nei Grandi Magazzini, il mio sguardo incrociò quello di una ragazza.
Era ferma davanti all’isola dei cosmetici. Arrossì mentre le sorridevo. E, io, non fui da meno. Ci guardammo, in silenzio, rossi fino ai capelli.
“Per caso, conosci questo?” mi chiese finalmente, mettendo fine al mio imbarazzo.
Ed esibì una boccetta di profumo che aveva scelto.
Lo conoscevo. Era regolarmente pubblicizzato su una delle tante riviste alle quali mio padre era abbonato ma, soprattutto, uno dei preferiti da mia madre.
“Ma certo. È molto secco. Sa di agrumi e di spezie”.
“Davvero. Me lo consigli?”
“Dovresti spruzzartene un poco sui polsi. I profumi cambiano tonalità a seconda della pelle di ognuno”.
Azzardai. Sicuro, già allora, della mia cultura in fatto di aromi.
Intervenne immediatamente la commessa. Le propose un test. Lei si lasciò spruzzare sui polsi, li agitò, li avvicinò alle narici. Dopo un attimo di riflessione, sorrise:
“Hai ragione. È delicatamente aspro di agrumi, ma con un adorabile contorno di qualcosa di morbido che non so definire. Vuoi sentire?”
Mi ritrovai una delle sue mani davanti al viso.
Senza riflettere la presi, delicatamente, e la avvicinai alle narici. Un meraviglioso mélange e, chissà come, mi venne in mente una frase, teatrale, da playboy navigato:
“Proprio uno splendido ‘misto pelle’. Ti sta benissimo”.
“Che bella espressione. Mi sarebbe piaciuto averla inventata. È proprio l’effetto che sento sulla mia pelle. Grazie. Lo prendo”.
Pagò, e mentre la commessa confezionava il pacchetto, riprese il flacone dimostrativo e si spruzzò ancora sui polsi e sul collo.
“Mi chiamo Noemi, e tu?”
Ero talmente imbarazzato che rischiai di farfugliare. “Enzo”, riuscii a presentarmi.
Uscimmo per strada, e non sapevo che cosa fare. Fu lei a decidere.
“Sei libero? Io fino alle 13. Dove andiamo?”
“Avevo previsto di andare a cinema. All’Orfeo ridanno ‘Gilda’, con Rita Hayworth e Glenn Ford. Ti va?”
“Splendido, non sono ancora riuscita a vederlo. Ma tu che cosa fai?
“Studio. Ma oggi avevo voglia di andare in giro. Forse perché dovevo incontrarti. E come vedi sono stato puntuale.”
Senza rendermene conto avevo vinto la timidezza e sfoggiato una frase sicuramente appresa da qualche film.
“Senti, senti. E io che pensavo fossi timido, come me.”
“Ma sono timido. È il mio modo di reagire. Mi hai un po’ guarito. E il timore è scomparso.”
“È successo così anche a me. E mi hai rassicurato. Mi piace parlarti”.
…
Non sapevo che cosa mi passasse per la mente. La scuola e le interrogazioni erano già nel dimenticatoio.
Prendeva forma il mio ideale del momento. Capelli biondi ma, con la stessa acconciatura di Cyd Charisse (che però era bruna), in uno dei primi musical arrivati in Italia.
Occhi di un verde incredibile, bocca carnosa, alta, belle gambe, falsa magra, elegante. Bella voce, nessuna cadenza dialettale.
‘Speriamo che riesca’, mi stavo dicendo mentre andavamo verso l’Orfeo.
“Studi anche tu. Sei all’università?” le chiesi mentre la guidavo in un bar.
“Siamo coetanei, ma non studio più. Aspetto di trovare un posto. In banca, forse. Ma presto ci trasferiremo. Quindi è tutto da decidere.”
Aveva detto‘ coetanei’, e io avevo parlato di università. Quindi credeva che avessi qualche anno in più.
In effetti, per via dell’altezza e del comportamento, molta gente riteneva che fossi quasi ventenne. E io non smentivo. Così anche Noemi che, all’incirca doveva avere quell’età, aveva fatto male i conti.
Meglio così. “Se scopre che ho sedici anni e qualche mese, saluta e se ne va”, pensai.
Ma la sua ultima frase, circa il trasferimento, mi aveva gelato.
Entrammo in un bar, le chiesi che cosa prendesse, e andai alla cassa già pensando alla sua partenza.
“L’ho appena trovata e sto già perdendola?”
La raggiunsi, allungai lo scontrino sul banco, e ordinai due caffè.
“Perché vai già via?” le chiesi tentando un tono normale, ma che già suonava disperato. Accidenti, non ero riuscito a nascondere il mio turbamento. Me ne pentii. Altro che vent’anni. Penserà che ne abbia dodici. Che figura.
“Che peccato. Ma tornerai presto?”
“Non tanto. Mio padre rappresenta un’azienda che lavora con l’estero. È stato in Sicilia per concludere degli accordi, e ora andremo via. Forse a Milano. Ma abbiamo ancora più di dieci giorni. Poi si vedrà. Adesso andiamo a cinema.”
…
In sala c’erano poche persone. In maggior parte studenti ‘omologhi assenteisti’.
Sedemmo in una delle ultime file. Stavano proiettando ‘La Settimana Incom’, in quegli anni, Il cinegiornale principe.
Noemi si tolse il cappotto, lo piegò con cura, lo mise sulla poltrona libera accanto a sé, e ci sistemò sopra la borsa. Si avvicinò, infilò un suo braccio sotto il mio e mi appoggiò la testa sulla spalla.
“Ti spiace se ti sto attaccata? Non vado a cinema da tempo e questo film, voglio proprio gustarmelo”.
Cercò, con naturalezza, le mie mani e le strinse, dolcemente, tra le sue.
Non riuscivo a dire una parola. Bloccato, sotto una cappa di timidezza, ed esaltato dall’inaspettato ‘colpo di fulmine’, rischiavo di rovinare tutto.
Ma certo, sarebbe partita. Però, se aveva accettato di venire a cinema e, ora mi si stringeva con tanta dolcezza, non le ero certo antipatico. Mi rilassai.
Sollevai il bracciolo che separava le poltrone, e le cinsi le spalle. Lei, letteralmente, si accucciò contro di me.
E il film cominciò.
Noemi seguiva attentamente. Ogni tanto mi chiedeva se sapessi di qualche curiosità sul ‘dietro le quinte’ della lavorazione.
Qualcosa, l’avevo appreso da alcuni articoli del Reader’s Digest al quale Papà era abbonato.
Le dissi delle liti furibonde tra Charles Vidor, il regista, e il produttore. Mi pare si chiamasse Cole, era gelosissimo della Hayworth, voleva eliminarne le scene d’amore con Glenn Ford. E insisteva. Al punto che Vidor stava per lasciare il film a metà.
Arrivò la famosa scena del ballo.
Rita, con un lungo abito da sera, nero senza spalline, cantava ‘Put The Blame On Mame’. Si sfilava i lunghissimi guanti, e li lanciava lontano.
Fu allora che sentii la carezza delle dita di Noemi sotto il mento. Dolcemente, mi obbligò a girare il viso verso di lei.
Mi baciò.
Rita cantava. Il nostro bacio continuò sino alla fine del brano. Ci separammo guardandoci, a lungo, in silenzio. Riprendemmo a baciarci, poi ad accarezzarci, come se in sala fossimo rimasti soltanto noi.
Il film finì. In silenzio riprendemmo i cappotti e uscimmo sul viale.

“È tardi. Accompagnami fino all’angolo di via Garibaldi e lasciami andare da sola. Mio padre ha un caratteraccio. Guai se mi vedesse con qualcuno.”
“Ti chiamo più tardi. Dammi il numero del telefono.”
“No, ti prego, dammi il tuo. Chiamo io. Oppure salta un’altra lezione. Vediamoci domani alla stessa ora, nello stesso posto. Sarà bellissimo.”
Camminavamo tenendoci per mano. Un passo dopo l’altro. Ogni tanto ci guardavamo. Mi accorsi che Noemi aveva gli occhi pieni di lacrime.
“Perché piangi?”
“Non so che cosa dirti. Questo incontro, è qualcosa di totalmente nuovo. Lo sento stupendamente bello. E mi terrorizza. Sarebbe meglio se non ci vedessimo più. Ho problemi molto gravi. Ed è inutile parlartene”.
Continuò a piangere, silenziosamente. Pescò degli occhiali da sole nella borsa, e se li mise.
La gente ci scorreva accanto.
Qualcuno ci urtava. Ma eravamo soli, in un deserto. Una sterminata distesa di sabbia, tutt’intorno. Nel gran silenzio.
Il calore della sua mano, tiepida, di seta, stretta alla mia. I pensieri, uno dopo l’altro, si inseguivano. Ma non riuscivo a capire che cosa fossero, né riuscivo a fermarli, per tornare al ragionamento che mi aveva, decisamente, abbandonato.
Diavolo, questo era ‘amore’. Quello descritto dai tanti scrittori che avevo scelto. Amore, certo. E ne parlavano in modo così sublime che, ogni volta, avevo pensato ad una splendida esagerazione.
E mi chiedevo, se mai avrei provato sensazioni così particolari. Da isolarmi dal resto del mondo, da cancellare ogni preoccupazione o qualsiasi pensiero e unirmi, con un sortilegio, a un’altra anima, ‘paziente’ della stessa malattia.
Mi riscosse la voce di Noemi.
“Fermati qui. Non cercare di seguirmi. Ti prego. Mi faresti del male.”
“Ci vedremo domani?” le chiesi, tentando di essere meno implorante possibile.
“Non lo so. Vorrei vederti con tutto il cuore, ma ho paura. Ti prego finiamo qui.”
“No, Noemi. Calmati. Domattina ne parleremo ancora. Non immaginavo che stessi cercandoti. Ora t’ho trovata, e ti voglio.”
“Va bene. Ma, se non verrò, non tentare di cercarmi. Prometti?”
“D’accordo. A domani.”
Ci sfiorammo le labbra. E corse via, dietro l’angolo.
Avevo promesso che non l’avrei seguita. Tornai indietro.
…
La sera, e la notte, furono piene di lei. E l’ora della felicità non arrivava mai.
La vidi mentre mi correva incontro, e corsi anch’io. Sembrava una scena da film.
E ci abbracciammo. Come reduci da una separazione di secoli. Nemmeno una parola. Baci, solo baci.
I passanti ci guardavano sorpresi. Non erano ancora arrivati i tempi delle libere effusioni. E la provincia, del sud, era ancora più avara di concessioni. Ma ci importava poco.
Ci rendemmo conto del nostro piccolo scandalo, e ne ridemmo. Mano nella mano, entrammo alla Upim, e percorremmo il dedalo tra le isole espositive. Guardavamo ogni cosa senza vederla. Ma, la nostra allegria sembrava contagiasse le addette alla vendita.
Le vedevamo sorriderci come se partecipassero al miracolo del nostro amore.
E fu l’ora del film ‘mattutino’. Tornammo allo stesso cinema. La proiezione era già iniziata. Non avevamo osservato l’àffiche del programma. Così, Rita Hayworth ci accolse, di nuovo, con la sua bellezza. Ancora ‘Gilda’? Nessun problema.
Anzi. Ridemmo, guadagnandoci degli “sssss, ssss, ssss” perentori dagli spettatori. Ignorammo anche quelli, e ci spostammo nell’ultima fila, già affollata da altre giovanissime coppie. I cappotti finirono su una poltrona libera.
E noi, uno contro l’altra. Come fosse l’ultimo abbraccio, prima del nulla.
 Guardammo soltanto la scena del ballo, e quella in cui Glenn Ford schiaffeggiava Rita. Uscimmo prima che il film terminasse. Entrammo in una famosa pasticceria, e presi un sacchetto di mandorle caramellate che ne erano la specialità.
Guardammo soltanto la scena del ballo, e quella in cui Glenn Ford schiaffeggiava Rita. Uscimmo prima che il film terminasse. Entrammo in una famosa pasticceria, e presi un sacchetto di mandorle caramellate che ne erano la specialità.
“Oggi sono libera fino alle 16”, mi disse Noemi, gustando una mandorla, “mi hanno detto che qui vicino c’è un lago. Faremmo in tempo a vederlo?”
“Ma certo, quello di Ganzirri. Ci va un tram. Passa qui vicino. Impiegherà una ventina di minuti.”
…
L’84 arrivò sferragliando. Salimmo sulla vettura di coda. Presi i biglietti e tornammo all’aperto, sul terrazzino posteriore.
“Che meraviglia, sembra di essere su uno dei tram di San Francisco. Quelli che vediamo nei film americani. È bellissimo.”
Sorrise Noemi, illuminando, ancora di più, se possibile, la scena. E mi si strinse addosso.
“Sai Enzo, sono felice. Mi sembra di tornare a ritroso nel tempo. Avevo dodici o tredici anni. Con papà e mamma, prendevamo un tram per il centro. Adoravo andare a piazza duomo. Allora c’erano poche automobili. Davanti a casa nostra passava un lungo tram. La circolare rossa. Faceva il giro della città. La prendevamo quasi ogni domenica. Così avevo imparato a conoscere Milano. Papà me ne indicava i quartieri, mentre li attraversavamo. E mi raccontava delle storie bellissime. Lui, ogni sera, quando io andavo a letto leggeva. Leggeva sempre. Aveva tanti libri. Alcuni, sin da quando fui alle medie, volle che li leggessi anch’io. Mi facevano sognare di città lontane e sconosciute. Immaginavo grandi amori, con giovani bellissimi e coraggiosi. Quei libri raccontavano sempre di cose belle, interessanti, spesso curiose. I personaggi, tranne alcuni forse, erano dolci e buoni. Si viveva bene a casa mia. Mai un litigio, mai una cattiveria. Poi un brutto giorno, una disgrazia e papà…”
“Papà che cosa? Mi hai detto che è qui con te e sta bene.”
“Sì, certo, mi sono confusa”, farfugliò Noemi arrossendo. “Non mio papà. Mi è venuto in mente di una mia amica. Una sera suo padre, uscì di casa e scomparve. Quella ragazza, giovanissima, e sua madre, rimasero sole e senza un soldo. Le cacciarono di casa. La ragazza non poté più andare a scuola. Sua madre accettò i lavori più umili. Riuscivano a malapena a sopravvivere. I sacrifici non bastavano mai. Ma questa è una storia triste. Oggi debbo restare felice. Stringimi, ti prego.”
Il tram fece una lunga curva, e apparve il lago. Un cerchio quasi perfetto con una fila di ville che ne disegnava i contorni.
Il panorama era completato dall’azzurro, ancora più intenso, del mare. Miracolosamente separato, lì accanto, da una sottilissima lingua di terra.

“Che meraviglia!” esclamò Noemi. E io, vincendo la congenita ritrosia a palesare troppo gli entusiasmi, la imitai.
“Davvero splendido. E quel sottile confine dal mare. È incredibile.”
Il tram riprese velocità, raggiunse la sponda del lago e prese a costeggiarlo.
La vegetazione sfoggiava i colori più impensati. Il verde intenso degli alberi di mandarino, punteggiati dal giallo dei frutti, si alternava a quello più scuro degli arbusti di camelie e gardenie, ravvivati dal bianco delle fioriture che, solo al sud, sfoggiano dimensioni così generose e fragranti.
E, intorno, una cornice di siepi, bucate da fiori di vari colori. Rigogliosi, ad onta della stagione invernale, allora, molto clemente in quelle zone.
Il capolinea era esattamente alla metà della circonferenza del lago. Al ritorno saremmo passati sull’altro versante, per rientrare sul binario che ci avrebbe riportato in città.
La nostra gita continuò con un giro dei negozi e dei locali affacciati sull’acqua. Noemi comprò un braccialetto d’argento. Io feci una gran fatica a rifiutarne un altro che voleva regalarmi ad ogni costo.
Durante la lunga passeggiata, volle entrare in una chiesetta. Una costruzione del secolo scorso, visibilmente bisognosa di un affettuoso restauro.
Bella, nel candore delle sue colonne. Il sole, filtrato dai cristalli multicolori delle grandi vetrate, la trasformava in un enorme caleidoscopio. Ma era, stranamente, fredda. Gelida.
Noemi si avvicinò a un altare laterale. Ospitava una statua della madonna, ed era illuminato da uno stuolo di ardenti candele votive. Ne accese un’altra, e mise un obolo nella cassetta delle offerte.
Si inginocchiò davanti al simulacro e, per qualche minuto, rimase in silenzio ad occhi chiusi. Quando si alzò, mantenne lo sguardo basso e si avviò, velocemente, all’uscita.
La distesa del lago ci riprese.
Noemi mi precedeva. Spedita. Sembrava ignorarmi. Mi sentivo a disagio. La seguii senza parlare, finché arrivammo davanti a un fioraio, vicino al capolinea del tram.
D’impulso mi avvicinai al banco e scelsi una rosa rossa, tra quelle col gambo più corto. Sapevo che le altre, decisamente più appariscenti, erano troppo costose per il poco denaro che avevo in tasca.
Raggiunsi Noemi e la accarezzai sui capelli. Si girò verso di me con gli occhi pieni di lacrime. Le porsi la rosa.
 “Splendida. Grazie. Sei dolce. Scusami sono davvero strana. Ogni tanto mi capita. Ti sei offeso?”
“Splendida. Grazie. Sei dolce. Scusami sono davvero strana. Ogni tanto mi capita. Ti sei offeso?”
“Ma no. Direi piuttosto preoccupato. Piangi. Ho fatto qualcosa di sconveniente?”
“Non potresti, mai, far nulla di sgradevole. Sono io che debbo ancora scusarmi. Certe volte mi vengono in mente pensieri orribili e, se non riesco a scacciarli subito, divento intrattabile. Oggi mi hai fatto felice. Ma so che non potrà durare. Ho troppi problemi.”
“Di che genere, forse perché dovrai partire o c’è qualcos’altro?”
“Ti prego, non chiedermi nulla. Sto bene. È passato. Stringimi.”
Invece, fu lei ad abbracciarmi. Cominciò a baciarmi con frenesia. Sentii che stavo arrossendo. La gente ci guardava, stupita.
Due ragazzi che si baciavano per strada, così appassionatamente ‘come al cinema’, non era tanto normale negli Anni 50.
E poi, in Sicilia.
Dolcemente interruppi l’abbraccio.
“Ti prego, ci guardano. Anch’io ho tanta voglia di te. Ma siamo al sud. Facciamo scandalo. Non hai idea. Sono capaci di scambiarti per una poco di buono. E tu sei il mio angelo.”
“Una poco di buono, e che differenza c’è. Da che cosa si riconosce ‘una poco di buono’. Sono vestita male, sono seminuda, ho atteggiamenti volgari? Pensi che potrei sembrare una di quelle che voi chiamate puttane?”
Era furente. Non piangeva più. Pallidissima, mi fissava con occhi di ghiaccio e infieriva. A bassa voce. Sibilando.
Ero esterrefatto.
“Noemi, che cosa ti succede. Non credo di aver detto nulla di offensivo. Volevo solo metterti in guardia contro le consuetudini della mia gente.”
“Becere, e ancora dure da sradicare. O meglio, ognuno in pubblico fa il puritano quale custode di incorruttibile moralità. Altro che un bacio innocente. Qui la regola consente di fare il peggio possibile. Ma, al riparo. Ogni donna, in apparenza è una sorta di ‘madonna illibata’. Poi, purché non la veda nessuno, può essere ‘Maddalena’.”
“È la regola, Noemi. Per usare termini biblici ‘si pecca più che altrove’. Ma guai a parlarne.”
“Però se tu, da forestiera, ti concedi un bacio innocente, ma in pieno sole, sei da lapidare. È il trionfo dell’ipocrisia.”
“Se il tuo soggiorno si prolungherà, potrai riderci sopra e dovrai, giocoforza, omologarti alla regola dell’apparire. Potrai concederti qualsiasi spazio e fare ciò che ti garba. Ma, intendiamoci, protetta da uno schermo molto spesso. Altro che quello quasi trasparente, di cui scriveva Petrarca. Ti calmi adesso?”
“Si, certo, forse hai ragione. Ma non credevo di aver fatto nulla di sconveniente baciandoti. Ho reagito male. Non succederà più. È tardi. Torniamo.”
…
Il tram ci riportò sul viale alberato del nostro incontro. Noemi era di nuovo radiosa.
“Vorrei ancora di quelle deliziose mandorle. Ma questa volta offro io. Vuoi?”
Una sosta nella solita pasticceria, appagò il suo desiderio. Ci avviammo, sgranocchiando la croccante specialità. La lasciai allo stesso angolo, con via Garibaldi, e incassai l’eloquenza del suo sguardo che mi suggeriva di non seguirla.
“Domani non potrò venire. Va’ a lezione. Ci vedremo il giorno dopo. Mi hai offerto una meravigliosa giornata.”
Ci sfiorammo le labbra, poi Noemi mi salutò ancora, agitando la rosa. Sull’angolo, svoltò e scomparve.
Mi venne in mente che l’indomani, nella prima ora avrei dovuto essere interrogato in filosofia. Dalla seconda, ci sarebbe stato il compito di greco. Due delle mie materie preferite e ne sarei uscito bene. Così andai alla fermata del bus n°4, per tornare a casa.
Il docente di filosofia mi era simpatico. Elegante e discreto. Al contrario dei suoi colleghi di quel liceo, sorrideva spesso. Suo figlio, Angelo, sedeva nel banco accanto al mio, ma non credo lo soddisfacesse molto. Al contrario del padre, non godeva di buone maniere e, come me, del resto, studiava poco.
L’interrogazione andò abbastanza bene. Anche se, a un certo punto, fui in difficoltà. Mi soccorse la solita estrosa inventiva che usavo in simili frangenti.
Senza la minima esitazione riuscii a spostare il discorso su un argomento diverso da quello che mi era stato chiesto.
Trovai un pretesto geniale. Dissi che avevo letto di certe opinioni “purtroppo non ricordavo su quale testo” ma, secondo me, le conclusioni potevano essere diverse… eccetera, eccetera, eccetera.
Il professore ne fu interessato. Avevo bleffato. Grazie alla mia memoria, spesso da encomio solenne, avevo riferito di un dibattito tra due intellettuali, ascoltato qualche giorno prima alla radio. Ovviamente citai quello originale, di uno dei due, e mi appropriai di quanto aveva ribattuto il suo interlocutore.
Feci un discorso perfetto. Ma, il colpo da maestro, fu l’esibizione, ad arte, di alcune incertezze mentre esponevo ‘la mia’ (si fa per dire) teoria.
Il professore mi fece i complimenti additandomi come esempio ai miei compagni e, soprattutto, rivolgendo uno sguardo, eloquente, a suo figlio.
Ero felice, e non mi vergognai affatto per il plagio. Nel tempo, avrei appreso quanto fosse diffusa l’abitudine di saccheggiare l’ingegno degli altri. Soprattutto tra famosi. E come, quasi nessuno dei derubati, tenti, nemmeno, una timida accusa. Per timore che si scopra quanto ha appena fatto ai danni di qualche altro.
Alla seconda ora arrivò l’antipaticissimo professore di greco.
Allampanato, col collo che sciacquava nel colletto della camicia (mai che ne accordasse una con l’abito), orribile anche la cravatta. Denunciava un nodo fatto una sola volta e, ogni giorno, allentato e poi ristretto, sino a ridursi a sorta di informe stoppino. Brutte le sue scarpe e la lisa borsa di pelle. Accessori, in carattere con lo sciatto globale del personaggio.
Scrisse il testo da tradurre sulla lavagna. Era un brano dell’Aiace di Sofocle.
Cominciai immediatamente a tradurlo.
Un messo arriva, trafelato, e si inginocchia ai piedi di Aiace. Gli dice che l’esercito troiano sta massacrando quello degli achei:
“Figlio di Telamone che l’isola di Salamina, d’ogn’intorno bagnata dall’onde, signoreggi. Se prospera sorte ti arride, anch’io sono felice. Ma se l’ira di Zeus ti colpisce, mi spavento e mi turbo come colomba che fugge…”
La traduzione mi riusciva facile e, come sempre, invece di sceglierne la forma letterale, cercavo di renderla più elegante e moderna.
Al primo compito, qualche settimana prima, il professore non aveva gradito. Anziché elogiarmi, mi aveva bollato con: “Esibizione da inutile saputello”, scritto con il pastello blu, in calce, alla traduzione.
Per questo, nelle occasioni successive, avevo aggiunto una seconda versione, a modo mio più gradevole. E lo avevo giocato.
Ma, da quel momento, aveva cominciato a dimostrarmi quanto non gli fossi simpatico. E, non perdeva occasione per tentare di mettermi in difficoltà.
Difficilmente ci riusciva. Ma la sua azione, aggiunta a quelle della maggior parte degli altri docenti, contribuiva a farmi disertare le lezioni. Continuai a tradurre. Riflettendo, parecchio, prima di scrivere.
Avevo deciso di redigere il testo in altra forma.
Quella classica, da opera teatrale qual era. Con i miei genitori, l’avevo apprezzato al teatro greco di Siracusa.
Redassi il testo non proprio in rima, ma con una resa quasi musicale. Mi imposi una sorta di scommessa con l’ignaro, antipatico, docente.
Un rischio, certo. Ma la cosa mi intrigava. Di sicuro feci più fatica. Ero stato costretto a memorizzare la traduzione, e immaginare di ascoltarla, per valutarne l’effetto.
Mi piacque, e finì nero su bianco.
Rilessi molto lentamente, ritoccai appena la punteggiatura, e consegnai il compito.
“Una sola edizione questa volta?”
Ironizzò l’antipatico.
“Oggi mi auguro di averla accontentata, professore. Ho immaginato lo stile, scelto dall’autore, per rappresentarla in teatro. Spero di aver interpretato alla lettera i suoi consigli.” Replicai con aria sottomessa e con gli occhi bassi.
“Vedremo se finalmente avrai recepito”, aggiunse con aria trionfante “Ma ho molti dubbi. Vedremo. Vedremo.”
Mise il foglio sul registro di classe, senza degnarlo di uno sguardo, e mi congedò con il solito, falso, sorriso. Sprezzante.
Tornando al banco feci una panoramica sui miei compagni. Mi guardavano senza capire che cosa avessi fatto. Ma non cambiai espressione. Gli lasciai credere che fossi umiliato. Sedetti, e presi a consultare il diario.
La campanella ci liberò.
I miei pensieri imboccarono l’identica via degli ultimi giorni. Pensavo sempre a Noemi, e all’impossibilità di telefonarle. L’indomani l’avrei rivista. Ma mancavano ancora molte ore.
…
Trascorsi il pomeriggio a studiare il commento di un canto della Divina commedia. Nei prossimi giorni mi avrebbero interrogato. Poi passai alla filosofia. Non potevo deludere il padre di Angelo. Prima della fine della settimana, sicuramente, anche lui mi avrebbe interrogato.
Nel tardo pomeriggio con i miei cugini, andammo a casa dei nonni. Vivevano anche loro a Messina. Tranne che nei mesi estivi, quando si trasferivano a Castroreale, nell’antico palazzo di famiglia, dove vivevo anch’io.
In città, i nonni avevano l’attico, di un elegante condominio, su Piazza Cairoli, la principale della città. Non erano da soli. C’era Agata, un’altra delle sorelle di mia madre. Bella e dolcissima. Dottoressa, entusiasta della professione, si dedicava anima e corpo ai suoi pazienti. “Sono anche loro la mia famiglia”, diceva. Fidanzata da anni con un noto dirigente, non era mai pronta a sposarlo.
La sua indecisione aveva antiche motivazioni. Negli anni della Seconda guerra mondiale era fidanzata “ufficialmente”, come usava dire allora in Sicilia, con un capitano della marina militare.
Comandava un sommergibile, affondato durante una missione. Era tutto pronto per il matrimonio. La tragedia sconvolse Agata e le cambiò il corso della vita. Aveva appena finito gli studi, si dedicò solo al lavoro. Non c’era altro che la interessasse.
Finché non conobbe quell’anima santa (si ironizzava tutti) che, dopo una lunghissima corte, era finalmente riuscito a farla innamorare.
La relazione sembrava calibrata ad altri tempi. Serate con amici, lunghe passeggiate, mai un viaggio insieme, mai nient’altro, credo.
Una vera ‘anima santa’ quell’uomo, al quale mi ero affezionato. Sempre paziente, gentile, e con una grande passione per l’eleganza. Forse anche questo aveva affascinato mia zia che, come le altre sorelle, era sempre rigorosamente al passo con la moda.
E, il piacere di un abbigliamento raffinato, mai chiassoso e appariscente, sembrava essere, originariamente, in dote a tutta la mia famiglia.
A cominciare dal nonno materno. Gentiluomo di nobili origini, in certo senso era stato un esempio da seguire. Sin da bambino. Mi aveva insegnato a leggere, a scrivere e ad andare in bicicletta, quando avevo poco più di tre anni. Mi affascinavano i suoi modi. I suoi abiti sempre perfetti, le camicie candide, le calzature capaci di fare da specchio. E il tutto, risaltava ancora di più, grazie a un fisico splendido. Altissimo, snello occhi celesti, mani curatissime e dovizia, infinita, di argomenti di conversazione.
…
Ma, torniamo a quel pomeriggio. Con i miei cugini prendemmo il bus e fummo a casa dei nonni. Facemmo merenda con delle paste alla crema e dei cannoli, ripieni di ricotta, che la nonna aveva fatto prendere dalla famosa pasticceria, sulla piazza, sotto i balconi del suo appartamento.
Il nonno mi regalò l’ennesimo libro, “La parola e la vita”, mi pare, di Giovanni Papini. Specie di, raffinato, manuale per evitare clamorosi errori di grammatica e di sintassi.
Tornammo nella villetta degli zii verso sera.
Erano rientrati tutti e due. La zia stava preparando la cena. Lo zio come da copione era immerso nella lettura. Ma quando arrivammo, mise da parte il libro e si mise a parlare con noi.
Cenammo. I miei cuginetti andarono a giocare in camera loro, Io mi sforzai di dedicare qualche attenzione a un canto della Divina commedia. Lo zio me ne aveva regalato un’edizione particolarmente rara, con un commento molto elaborato.
Mi concentravo a fatica, perché i miei pensieri continuavano a marciare a senso unico. Noemi imperava su tutto. L’indomani avrei nuovamente saltato le lezioni e l’avrei rivista.
…
Al punto dell’incontro, arrivammo tutti e due in anticipo. Era bellissima.
“Ciao”
“Ciao”
E ci abbracciammo. Come reduci da una lunga, reciproca, separazione.
Il dialogo si fermò al ‘ciao’. In silenzio, tenendoci per mano, ci dirigemmo al solito cinema. Eravamo, ancora, in anticipo.
In programma, ‘Spettacolo di varietà’, un musical con Fred Astaire e la mia meravigliosa Cyd Charisse.
Sedemmo nell’ultima fila, scegliendo le poltrone, all’estrema destra. Restavano quasi sempre deserte, per via di una colonna che limitava la visione dello schermo.
Via i cappotti. Restammo abbracciati, con gli occhi chiusi per un tempo che ci sembrava piacevolmente lungo. Solo dopo, cominciammo a baciarci e poi ancora a stringerci. Come per opporci a qualcuno, invisibile, che tentasse di separarci.
Del film guardammo pochissimo. Ne gustammo il commento musicale. Come l’avessero composto, in esclusiva, per noi.
Uscimmo sul viale San Martino, l’arteria centrale di Messina. Qualche passo e il profumo, che annunciava la pasticceria delle mandorle caramellate, ci avvolse, provocante. Prendemmo il solito cartoccio e tornammo sul viale.

“Fra una settimana torneremo a Milano”, mi disse Noemi con un filo di voce, tenendo la testa bassa.
Sembrò mi avessero colpito allo stomaco. A malapena sussurrai:
“Milano, e poi?”
“Non so dirti nulla. Può darsi che papà debba trasferirsi ancora. E noi con lui. Come sempre. Ti scriverò, prometto.”
Immobili sul marciapiedi, ci guardavamo negli occhi, sempre più umidi.
Un tram passò annunciandosi con il classico scampanellio che ne anticipava lo sferragliare. Non tentammo nemmeno un passo. Distolsi lo sguardo dal verde profondo che già adoravo. Ma, chissà perché, spostai lo sguardo sulle vetrine, ai lati dell’ingresso, di un piccolo negozio di giocattoli e cianfrusaglie.
Allineati su una delle mensole centrali, una sfilza di orologi da polso dedicati ai personaggi di Walt Disney.
L’effige di Topolino, sul quadrante dei primi due della fila, era animata. Le grandi orecchie di Micky Mouse oscillavano in sincrono. Stupidamente ne fui affascinato.
“Enzo, ti prego, non farmi soffrire ancora di più. È stato bello incontrarci. Abbiamo ancora una settimana. Poi, chissà, troveremo una soluzione. Non farmi piangere. Ci guardano. Debbo tornare a casa, è tardi.”
“Hai ragione, scusami, andiamo.”

Abbracciati, seguimmo il ‘solito’ percorso. Attraversammo il viale. Giù sulla leggera discesa, fino al ‘solito’ incrocio, davanti all’ingresso che sfociava nel cortile del ‘solito’ palazzo.
Noemi mi sfiorò le labbra con un bacio. Ma le lacrime, erano tornate. E si mischiarono alle mie che, inutilmente, tentavo di frenare.
“Sta’ tranquillo, ci vedremo domani. Stesso posto, stessa ora. Non sbagliarti.”
E tentò, senza successo, un sorriso.
L’abbracciai. La baciai sui capelli, poi dolcemente, sulla bocca. Il nostro, consueto, delicato commiato.
“Va bene. A domani”, e attesi che scomparisse svoltando dietro l’angolo del palazzo.
Come sempre. Ma, quella volta, non tornai sui miei passi. Mi precipitai nell’ingresso di quello stabile, e fui nel cortile.
Come nella maggior parte dei condomìni di Messina, il cortile aveva quattro uscite, una per ogni lato. Regola come quella, ferrea, istituita dopo il catastrofico terremoto del 1908, che limita l’altezza dei fabbricati, e prescrive, possibilmente, le quattro vie di fuga, per facilitare l’esodo degli inquilini, in caso di malaugurate emergenze.
Attraversai il cortile, e uscii, dalla parte opposta, sul viale parallelo.
Noemi camminava, poche decine di metri, più avanti. Cominciai a seguirla, con molta accortezza. Lei non si guardò mai alle spalle.
A un certo punto, svoltò a sinistra e sbucò sul vialone. Davanti alla serie dei palazzi che celavano la visione del mare dello Stretto.
Camminava veloce. Non c’erano negozi e, in giro, poca gente. Rischiavo di farmi scoprire e dovevo, continuamente, nascondermi nei portoni o accucciarmi dietro qualche rara automobile in sosta.
Che strana zona, non certo malfamata, ma poco adatta a una famiglia agiata, come, immaginavo, quella di Noemi.
Lei, aveva ancora accelerato.
Per fortuna, accanto al marciapiedi, era parcheggiata una lunga fila di camion. Davanti a diversi magazzini di accessori per l’edilizia.
Stavo riflettendo sull’inseguimento. E se mi avesse scoperto? Che figura. Lei si era fidata. Non osavo immaginare le conseguenze.
Noemi si fermò. Riuscii, miracolosamente, a guadagnare lo schermo di un furgone, perché lei si girò, e guardò dalla mia parte. Poi, dal movimento del braccio, capii che aveva suonato a una porta che, io, però, non vedevo.
Certo le aprirono, subito, perché scomparve.
Lasciai passare qualche secondo e mi mossi.
Arrivai a un portoncino, lucidissimo, elegante. In contrasto con gli omologhi dei dintorni.
Al centro, sopra il campanello, un’unica, scintillante, targa di ottone.
Sul metallo, in svolazzanti, caratteri barocchi, erano incise, due parole:
“Suprema Georgette”. Il casino più chic di Messina.
Non riesco a ricordare che cosa avessi provato.
Di quella casa di tolleranza sapevo, solo, per sentito dire. Da sedicenne, non avevo, certo, potuto accedervi.
Schiacciai con rabbia, a lungo, il pulsante del campanello. Aprì una donna anziana. Non fece in tempo a parlare. La scansai con violenza e mi trovai di fronte a una scala. Presi a salire, di corsa.
Gridavo, ne sono certo, il nome che amavo.
In cima alla scala, si apriva una grande sala. Deserta. Lungo le pareti, piccoli divani si alternavano a poltroncine. Su un lato, una sorta di bancone di legno, alto e lucidissimo. Sorgeva davanti a qualcosa di simile a quanto avevo visto nelle cucine di un grande albergo. C’ero andato con papà che doveva progettarne il restauro. Mi era rimasta impressa quella specie di bacheca con tante nicchie, ognuna con una piccola lampada, al centro, sovrastata da un numero e da un pulsante.
Da lì, partiva un lungo corridoio con tante porte.
Una dopo l’altra, si aprirono. Certo attirate dalle mie grida, uscirono alcune ragazze, e mi corsero incontro. Con loro una donna matura, inguainata in una lunga vestaglia. Scarmigliata, i capelli rosso fiamma, il volto paonazzo, mi indirizzava parole minacciose.
La spinsi da un lato, e corsi nel corridoio.
Noemi apparve sul fondo.
Immobile. Pietrificata.
La raggiunsi. Ma non riuscii a parlare.
Le urla della donna alle mie spalle, si placarono. Il silenzio sublimò la sceneggiatura del dramma.
Furono i nostri occhi a urlare. E ci abbracciammo.
Il corridoio fu deserto. Noemi mi prese per mano e mi guidò, piano, nella sua camera.
Chiuse la porta, mi si strinse addosso con violenza e, finalmente, la disperazione ritrovò la voce, nell’eco dei singhiozzi.
Piangemmo. Piangemmo a lungo. Abbracciati fin quasi a soffocarci. I baci arrivarono. Sembrava non fosse accaduto nulla.
Ci baciammo. Ma in modo diverso. E ognuno, fu costretto a gustare le lacrime dell’altro.
Non so quanto tempo fossimo rimasti così.
Poi accadde quanto non avrei mai immaginato. E cominciammo a fare l’amore.
Non mi resi conto del come fosse accaduto, né come i nostri abiti si fossero staccati da noi. E ci trovammo uniti ad amarci con una struggente tenerezza.
Sembrava che la magia dovesse durare all’infinito. Perché, senza dubbio, eravamo fuori dal tempo. Ci guardavamo negli occhi, ci baciavamo, esaltando la comunione dei nostri corpi.
E fu un crescendo di sensazioni. Come se il miracolo che ci univa, fosse esistito da sempre. E quando, con una violenza inaspettata, la meraviglia ci fuse. Con la stessa esaltazione di naufraghi, arrivati a un appiglio di salvezza.
Per tutta la settimana, grazie alla inaspettata complicità della responsabile della ‘casa’, fui ammesso in quel luogo, altrimenti, proibito. Non riuscivo a staccarmi da Noemi, anche se mi costava un’assurda simbiosi, di sofferenza e passione.
Stavo con lei, qualche ora, ogni mattina. E, la lasciavo prima che subisse lo scempio.
Restavamo abbracciati, senza parlare. Poi facevamo l’amore. Ogni volta era sempre più bello. Ma seguiva lo strazio.
Ci guardavamo disperati. Senza tentare una sola parola che ipotizzasse il futuro. Le lacrime, poi i singhiozzi, prendevano, spesso, il sopravvento.
Non ero più andato a scuola. Non riuscivo a dormire, né a pensare. La visione di Noemi, offerta in pasto a chiunque volesse possederla, mi tormentava.
Senza meta, andavo in giro per la città. Come dovessi espiare una colpa mai commessa. E ignoravo qualsiasi cosa, e chiunque mi fosse intorno. Al porto, seduto su una panchina, guardavo il mare. Per ore, senza vederlo.
Passarono cinque, sei giorni o più. Non ricordo. Vuoti di tutto.
Tornavo a vivere solo nei momenti, meravigliosi, e orribili, accanto a Noemi. Finché i miei sedici anni, violentati, ritrovarono la ragione.
Dissi agli zii che sarei tornato a casa.
“O rischierei la bocciatura”, mi giustificai.
Mi accompagnarono in stazione. Lasciai la valigia al deposito bagagli, e andai da Noemi.
La ‘casa’ era abbastanza vicina.
L’orario del mio ‘accesso’ era passato da un pezzo. Ma pressai, ugualmente, quell’odiato campanello.
L’addetta all’ingresso, ormai mi conosceva. Tentò, solo debolmente, di fermarmi.
La evitai con dolcezza, e mi lasciò passare.
In cima alle scale, mi si aprì la visione che avevo sempre evitato di immaginare.
Al bancone della maitresse, Noemi, stava salutando il suo ultimo cliente, impegnato a saldare il conto.
Mi vide, e mi fece cenno di andar via. Lo ignorai. La raggiunsi e, sotto lo sguardo allarmato della padrona, la presi sottobraccio e la spinsi nel corridoio.
“Non puoi stare qui. Vediamoci domani. Ti prego.”
Ricacciai in gola un singhiozzo. Entrammo nella sua camera. In un attimo, cambiò tutto.
Avevo varcato la soglia, maledetta, ma capace di portarmi fuori dal mondo.
Noemi. Noemi.
Mi bastò guardarla. Le lacrime ci scivolavano sulle guance, e mi persi nei suoi occhi.
“Ti amo. No. Non dire nulla. Debbo memorizzare la tua immagine. La meraviglia dei tuoi occhi, del tuo corpo. E il suono della tua voce. Non i singhiozzi. Amore dolce, è il nostro saluto d’addio. Non ti dimenticherò. Mai. Ne sono certo.”
La baciai teneramente, come temessi di farle male. Sulle labbra, poi sui capelli.
Lasciai la camera. Ne chiusi, piano, la porta, senza girarmi a guardare indietro. E mi avviai all’uscita.
…
L’antico liceo, mi concesse il rientro in classe. La ripresa impegnò tutta la mia volontà. E non solo per lo studio.
Ero impegnato a cancellare quel momento di vita appena vissuto. Sublime e devastante. O, riprovare amore, mi sarebbe stato, per sempre, impossibile.
Credo d’aver fallito. Se, dopo decenni, le immagini, le sensazioni e i suoni, di quei giorni sono, ancora, nitidi e corposi.
Sicuramente, tra i più rievocati. Causa del vezzo, involontario, di ‘ruminare’ ricordi. Come uso fare. E ogni giorno di più.
L’eco di quell’amore, meraviglioso e impossibile, è tutt’ora viva. Con l’oscena delusione, la sofferenza e la rabbia. Consolidate, sin da quei giorni, in assoluto cinismo.
Inutile, qualsiasi tentativo di riportarmi a credere nella possibile, invocata, sincerità di qualsiasi successiva relazione.
Mio malgrado, ho trasfigurato il dolore. Nient’altro che ricerca, frenetica, di nuove, troppe, morbose, esperienze.
Ma, attento a troncarle. Prima che somiglino a un amore. Una missione. Di rivalsa, espiazione, o, forse punitiva?
In realtà, disperata ansia di guarigione. Da una patologia incurabile.
O una condanna? Forse.
(2023)


Immagini di rete usate per scopi puramente illustrativi.
Ai legittimi proprietari ogni diritto di copyright.
- La quale… [parte II] - 26 Maggio 2025
- La quale… [parte I] - 26 Maggio 2025
- La terra della talpa - 20 Maggio 2025