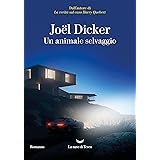Parlando dei libri che ho amato e che amo tuttora e che vorrei che la mia trentina di lettori (mi ritengo più letto di Manzoni) amassero anche loro, li mescolo a storie della mia vita collegate per circostanze di tempo con il libro letto.
Parlando dei libri che ho amato e che amo tuttora e che vorrei che la mia trentina di lettori (mi ritengo più letto di Manzoni) amassero anche loro, li mescolo a storie della mia vita collegate per circostanze di tempo con il libro letto.
È la primavera del 1989.
È un viaggio di lavoro della vita: gli Stati Uniti e a seguire il Canada, presso i Consolati italiani a insegnare a impiegati dei consolati come si adoperano le procedure di consultazione degli archivi INPS di recente connessi.
Noia mortale, pochi impiegati hanno voglia d’imparare e per tenerci occupati ci organizzano incontri con i vari rappresentanti della Comunità Italiana.
Incontrare tanti personaggi alla Don Vito Corleone non è il massimo della vita e non resta che dedicarsi al turismo, ne darò conto di ciò in un’altra occasione.
Ma per mia fortuna mi ero portato dietro da leggere: l’ultima uscita di Gesualdo Bufalino, Le menzogne della notte.
E leggere Bufalino alle 4 del mattino di New York, appena sveglio per effetto del jet lag è il massimo della vita.
Dalla finestra della mia stanza che guarda sull’ingresso posteriore del Waldorf Astoria, vengo preso dalle parole di Bufalino e trasportato in un’isola penitenziaria borbonica, insieme a un gruppo di condannati a morte a trascorrere con loro l’ultima notte sullo sfondo di uno stravolto Risorgimento.
La storia, in breve per chi non la conosce, è questa.
Vi sono quattro prigionieri, rei confessi di lesa maestà per un fallito attentato alla vita del sovrano che ha provocato vittime innocenti: il barone di Letoianni, Corrado Ingafù, di età matura, gentiluomo di corte, il sedicente poeta Saglimbeni, autore di pasquinate contro il trono e l’altare, il soldato trentenne Agesilao degli Incerti di natali bastardi e il giovane Narciso Lucifora.
Tutti accoliti di una setta segreta capeggiata da un misterioso Padreterno di cui, pur sottoposti a tortura, non hanno rivelato l’identità.
Nell’imminenza dell’esecuzione, il governatore del carcere Consalvo De Ritis, fanatico lealista, guercio e roso da un male inesorabile, viene a proporre ai quattro un patto odioso. Nella cella-confortatorio, riservata alle ultime ore dei condannati al patibolo, troveranno una cassetta in cui potranno, anonimamente, imbussolare ciascuno un foglio; se almeno uno recherà il nome del fantomatico Padreterno, tutti avranno salva la vita. Trasferiti nel confortatorio, v’incontrano un altro compagno di pena, che ha patito la tortura e ha il capo avvolto in bende insanguinate: il frate Cirillo, un brigante sanguinario e devoto detto frate per burla. Fra Cirillo, che con cinismo irride alla loro fede liberale, propone di occupare le ore angosciose dell’attesa raccontando ciascuno, come in un Decamerone notturno, un felice momento da ricordare sotto il filo della mannaia.
Quattro storie cui si aggiunge la quinta di Fra Cirillo e l’epilogo che non voglio svelare.
Esse diventano capitolo dopo capitolo, sempre più avvincenti, fino all’inaspettata conclusione che chiude meravigliosamente il cerchio su questa indimenticabile storia di menzogne notturne.
Lo consiglio vivamente con il mio solito tormentone: Accattateville.
Voglio invece raccontare una storia, di una menzogna stavolta svelata.
Ho il week end libero da impegni ed è arrivato finalmente il momento di togliermi quella repressa curiosità che mi son portato appresso da quando sono sbarcato al JFK: ritrovare le tracce perdute da circa venticinque anni di Eugenia.
Era Natale del 1963 e l’ultima lettera era ritornata dall’America con la scritta: transferred, address unknown.
Appena arrivato al Consolato, ho chiesto a un impiegato poco curioso e molto disponibile di controllare all’Anagrafe se il padre di Eugenia abitasse ancora al vecchio indirizzo 260 W 43rd St.
È ancora quello.
Ho il week libero, per cui dopo aver divorato Le menzogne della notte, è arrivato il tempo della verità del mattino.
Alle 8 in punto mi vesto di corsa, jeans, scarpe comode, giubbetto di jeans, dopo una settimana di giacca e cravatta ne ho ben diritto.
Con la mappa della metropolitana trovo l’indirizzo, è all’incrocio con l’Ottava Avenue, un isolato dalla fermata della Metro del Terminal Bus di Port Autorithy.
A passo di corsa faccio tutto l’isolato, sull’Ottava una folla di pendolari scesi dagli autobus, nonostante fosse sabato.
All’angolo della 43rd cambia lo scenario.
Marciapiedi stretti, ingombri di sacchi neri di rifiuti che quasi tracimano sulla strada. L’indirizzo è un palazzo in pietra grigia, stretto e basso, di fianco un’erboristeria cinese.
Sul portone la pulsantiera del citofono con una griglia antivandali.
Il nome c’è.
Suono.
Una voce metallica risponde: «Hallo.».
«Signor Fauceglia? Vengo dall’Italia. Le vorrei parlare. Sono Raffaele, quell’amico di Eugenia. Si ricorda di me?».
Qualche istante di silenzio.
Lo scatto della serratura e la stessa voce: «Sali, quarto piano, appartamento n. 12, l’ascensore è guasto, da anni.».
Faccio le scale di corsa, odore di muffa, tanfo di vino, graffiti sulle pareti.
Sulla porta una targa d’ottone con i caratteri in corsivo sbiaditi dagli anni.
Un campanello a chiavetta. Busso.
Rumore di chiavistelli, la porta si apre lentamente.
È lui: Pietro Fauceglia, il padre di Eugenia.
È cambiato tanto dopo trent’anni, è molto più magro, i capelli una volta neri sono tutti grigi, come i baffi.
E dal collo sbuca quella macchinetta dei tracheotomizzati.
Sulla parete di fronte alla porta un poster tratto dalla foto di Pietro in divisa della X MAS.
Mi ricorda quella foto, ai tempi la teneva nascosta.
Ora a New York quelle mostrine e quella divisa non hanno alcun significato.
Un sorriso triste. «E tu che ci fai qui? Sei rimasto uguale e con la stessa fantasia. Non immaginavo di vederti dopo tanti anni.».
Gli carezzo il volto: «Voglio sapere notizie di Eugenia. Dopo quell’ultima lettera del Natale del 1963, restituita con l’annotazione trasferita, indirizzo sconosciuto, mi è rimasta dentro la curiosità e poi a Eugenia volevo bene, un amore di bambini, continuato da lontano con tante lettere.».
Pietro ricambia la carezza e: «Mettiti seduto, ti spiego tutto. È giusto che tu lo sappia. Vedi quella lettera l’ho fatta restituire io, con quell’annotazione, ma su ordine di Eugenia. Lei l’aspettava per Natale. E arrivò giusto in tempo, il giorno della Vigilia. Ma Eugenia non c’era più, se ne era andata due giorni prima, allora con la leucemia non c’era scampo. È rimasta lucida fino alla fine, sembrava che stesse bene e che potesse tornare a casa per Natale. Poi chiuse gli occhi e non li riaprì. Poco prima mi disse, se arriva quella lettera e non ci sono più, restituiscila. Non voglio che lo sappia. Questa è la verità.».
E quella mattina del 25 marzo 1989 lacrime silenziose e vere nell’appartamento n. 12 del 260 W 43rd St.
——————————————————
Ringrazio per l’editing Maria Laura Villani
- Le apparizioni di Gesù risorto - 20 Febbraio 2017
- Un vizio capitale: l’invidia - 6 Febbraio 2017
- La melodia dell’amore - 30 Gennaio 2017