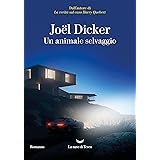Questo racconto, vietato ai deboli di cuore, è liberamente ispirato alla vita e alle gesta di Nicolas Claux, “il vampiro di Parigi”. Dopo aver scontato una breve pena per omicidio, Nicolas attualmente è vivo e libero. Per mantenersi, pubblica periodicamente un calendario dei serial killer che disegna lui stesso, come vedete nella foto.
Il Calendario del Male (Memorie, business e speranze di un vampiro moderno)
 Nel vizio ci vuole stile. La mia opinione è che bisogna meritarselo, soffrire un po’, insomma. Altrimenti, se uno peccasse sempre, come diceva nonno Nicholas, per trasgredire dovrebbe compiere una buona azione. Mi chiamo Jeremiah Cailloux, meglio noto come «il vampiro». Nessuno può pretendere una buona azione da un vampiro. Giusto? Giusto. Coerentemente devo regolarmi da me. Come dicevo, è una questione di stile e di coscienza. Pagarmi il biglietto per il male, meritarmelo. Perciò stamane ho preso la linea 12 ma sono sceso ad Anvers. È quasi ferragosto, si schiatta dall’afa, l’arrampicata a piedi verso Montmartre un autentico calvario. Ma che spettacolo! Rue Lepic è un’ascesa dolorosa verso il cielo dei cieli, quello dell’arte, e Montmartre sembra il dito di un genio che sgrida Parigi. Non posso certo considerarmi un maestro come Delacroix, Utrillo, Modigliani, Van Gogh e Picasso, che resero leggendaria questa collina, ma durante sette anni di carcere ho raffinato la mia tecnica pittorica che non ha nulla da spartire con gli imbrattatele che ormai infestano Montmartre, e grazie ai bei ritratti di serial killer un giorno diventerò ricco e famoso. Nel frattempo, sono spesso ospite di talk show su Antenne 2, solo in qualità di vampiro non di artista, perché il sangue fa drizzare l’audience più di un quadro o di uno spogliarello.
Nel vizio ci vuole stile. La mia opinione è che bisogna meritarselo, soffrire un po’, insomma. Altrimenti, se uno peccasse sempre, come diceva nonno Nicholas, per trasgredire dovrebbe compiere una buona azione. Mi chiamo Jeremiah Cailloux, meglio noto come «il vampiro». Nessuno può pretendere una buona azione da un vampiro. Giusto? Giusto. Coerentemente devo regolarmi da me. Come dicevo, è una questione di stile e di coscienza. Pagarmi il biglietto per il male, meritarmelo. Perciò stamane ho preso la linea 12 ma sono sceso ad Anvers. È quasi ferragosto, si schiatta dall’afa, l’arrampicata a piedi verso Montmartre un autentico calvario. Ma che spettacolo! Rue Lepic è un’ascesa dolorosa verso il cielo dei cieli, quello dell’arte, e Montmartre sembra il dito di un genio che sgrida Parigi. Non posso certo considerarmi un maestro come Delacroix, Utrillo, Modigliani, Van Gogh e Picasso, che resero leggendaria questa collina, ma durante sette anni di carcere ho raffinato la mia tecnica pittorica che non ha nulla da spartire con gli imbrattatele che ormai infestano Montmartre, e grazie ai bei ritratti di serial killer un giorno diventerò ricco e famoso. Nel frattempo, sono spesso ospite di talk show su Antenne 2, solo in qualità di vampiro non di artista, perché il sangue fa drizzare l’audience più di un quadro o di uno spogliarello.
A metà strada per la macelleria di Marguerite, il mio nuovo amore, sono entrato all’Electrolux e ho finalmente ordinato il frigorifero Magnum a due porte, da incasso. Come l’ho carezzato ho smesso di sudare. Il nuovo Magnum della Electrolux, un cherubino del gelo, è talmente bianco e invitante che stasera, non appena me lo consegneranno, ci dipingerò due gigantesche labbra rosse femminili, quelle della macellaia Marguerite. Sin da bambino io amo tutto ciò che è gelido. Il prezzo, tuttavia, era vergognoso, e devo dire grazie alle mie fan, altrimenti non me lo sarei potuto permettere. Da quando iniziai a dipingere ritratti, chiuso nel carcere dei serial killer francesi, non hanno mai smesso di comprarmeli per corrispondenza. Che care! Hanno mariti brutalmente onesti, di quella sonnacchiosa moralità degli impiegati che tengono a freno la loro cattiveria per vigliaccheria, e le spupazzano una volta a settimana con la virilità deprimente della gente perbene. Le anime delle mogli, invece, voragini insondabili, vere autostrade dello spirito smarrito, sono nude e disperate, più deserte della loro vagina, che nessuno colma. Io le faccio sognare. A proposito di sogni, il mio è quello di realizzare un Calendario del Male. Non si capisce per quale ingiustizia, infatti, a oltre tre quarti del genere umano sia negato un calendario. Noi che non siamo buoni rappresentiamo la maggioranza della terra! Invece, nelle nostre cucine, sui tir, a scuola, negli uffici o nelle fabbriche, per sapere che cavolo di giorno sia, dobbiamo sorbettarci la pappardella su un martire o su un santo, una vergine o una santissima ricorrenza. La mia idea rivoluzionaria è di non farci più vivere sfasati, con il cuore, la mente e le gambe che tirano da una parte e i fogli di calendario dall’altra. Giusto? Giusto.
Per esempio, oggi, 11 agosto 2009, sui calendari si festeggia santa Chiara d’Assisi, vergine. Sul mio Calendario del Male, al contrario, si celebrerà la data di nascita di Kira Kener, attrice pornografica statunitense. Ma anche l’11 agosto del 1973, la sventurata sera in cui si suicidò Giorgino William Vizzardelli, killer di Sarzana, un italiano sveglio, che a soli quattordici anni uccise due sacerdoti a colpi di scure, poi un tassista, quindi un barbiere, persino il custode del registro delle tasse, tanto da far smaniare Mussolini che non riusciva ad acciuffarlo nonostante l’OVRA, la polizia segreta fascista.
Parigi, Montmartre, 11 agosto 2009, mezzogiorno Sulle pagine del Calendario terrei per me soltanto cinque o sei date. Le pietre miliari della mia vita. Sono ancora giovane, spero di poter inserire qualche malefica ricorrenza in più, chissà, magari proprio questa di oggi. Ma con il male non si può mai dire, va e viene come la marea, non ha un orario prestabilito tipo le cameriere, e neppure il giovedì libero, tu devi dedicarti al compito nero anima e corpo, in attesa di cavalcare l’onda giusta. Il nostro è un mestiere per pochi eletti, ci vogliono concentrazione, rigore, una geniale ispirazione, e una valanga di circostanze coincidenti. L’unico paragone possibile è con Beethoven e il primo accordo dell’Eroica. Quante volte si sarà seduto al pianoforte in attesa che gli venisse precisamente quello? Mi auguro che oggi sia la mia giornata memorabile, la data in cui suonerò il mio accordo eroico. Al momento, è l’ennesima mattina d’agosto che trascorro davanti alle vetri- ne della Macelleria Roger di rue Lepic, apparendo e scomparendo come una lucciola. Che altro potrei fare? Marguerite è il mio amore, ma dovrà scoprirlo solo nel preciso momento in cui saprà di essere la mia vittima. Il momento beethoveniano. L’ispirato attimo sinfonico del male. Giusto? Giusto. Oggi a vampirizzare il prossimo sono buoni tutti, dalle banche agli amanti. Una donna ti concede la sua mano come una banca ti eroga un prestito. Ma scorrono mesi, anni, a volte una vita intera, prima di scoprire che quell’elargizione di denaro o d’amore, a prima vista così generosa, ti ha dissanguato. Lo stile di un vampiro perbene è di regolare i conti nello stesso gesto. Un dare e avere sublime. Amore e morte congelati in un istante e per sempre.
Marguerite, la macellaia, ha una trentina d’anni come me, capelli rossi, occhi verdi, una costellazione di efelidi su un corpo da star sudamericana, e seni a forma di piccoli dirigibili che sembrano rigonfi d’elio. Quando il negozio è deserto come adesso, l’ardita macellaia posa i seni sul bancone sagomato, un gioiello tecnologico del freddo, una bara di cristallo, e contempla trasognata gli abbaini di rue Lepic. A mia volta, al di là della vetrina, sul marciapiede di fronte, mi appoggio nella stessa posa sul tetto di un’auto, con l’indice puntato alla tempia, e quando lei cambia posizione, lo faccio anch’io. Se Marguerite ripiega la testa di qua, la mia s’inclina di là. Siamo un muto orologio a cucù gemello che batte placido le ore in attesa che venga il nostro tempo. Chissà che cosa sogna la macellaia? Io m’immagino i suoi seni che prendono il volo nel cielo azzurro mentre su Parigi piovono fresche goccioline di sangue rosa. È così raggiante, Marguerite! Sotto i seni è adagiato un tesoro di bistecche appetitose in vendita, dal maiale al cervo (lei aggiorna i prezzi sui cartellini con una grafia infantile e li infilza nelle carni come croci). Dal soffitto, le pale di mogano dei ventilatori sfrigolano la sua camicetta di seta bianca e soffiano sulla massa di capelli rossi, che sobbalzano come soffici nidi di polvere. Così mi apparve casualmente a metà luglio, lo stesso giorno che notai il Magnum della Electrolux, due isolati più in giù. Da allora, le due immagini si sono sovrapposte e saldate insieme: Marguerite e il Magnum. Amo entrambi. La macellaia di rue Lepic in frigorifero è la visione della morte più erotica che abbia mai avuto. Fra noi, fino a stamane, non una parola, soltanto un rito. Tutte le mattine, verso l’una e mezza, decine di gatti del quartiere mi strusciano le gambe. Si sono precipitati qui, aizzati come me dagli oscuri richiami del sangue. Prima di abbassare le saracinesche per la pausa pranzo, Marguerite, generosa come la sua scollatura, distribuisce ai gatti di Montmartre un grosso sacchetto di frattaglie. Nel rovesciarlo, si piega quasi a terra, mentre i seni continuano a puntare il cielo come piccoli Zeppelin, gli audaci dirigibili della Luftwaffe. Soltanto allora, accovacciata tra i felini, Marguerite solleva lo sguardo compiaciuta verso di me, l’estraneo, e commenta con un cenno complice la voracità dei gatti. La prima volta sono arrossito, ora non più. Eppure non riesco a spiccicare una parola. In quella zuffa di peli e interiora, di profumo di femmina e gatto, fra brandelli contesi di carni e ossa, assaporo l’estasi della mia prima volta, in una meravigliosa chiesa nei dintorni di Praga. Sarà la prima delle pagine che mi dedicherò nel Calendario del Male, fra le gesta di Satana Manson, l’assassino di Sharon Tate, e il 4 aprile del 1968, una delle massime maligne ricorrenze, il giorno storico in cui San James Earl Ray liquidò, con una rivoltellata, quel rompiballe di Martin Luther King.
Kostnic, chiesa delle Ossa. Kutna Hora (Praga), 22 marzo 1982 Per festeggiare il mio decimo anniversario, nonno Nicholas mi portò a Praga. Ho sempre adorato i picnic col pranzo al sacco, e così, la mattina del compleanno, mio nonno comprò un pollo arrosto con patate, una deliziosa torta di ribes, una bottiglia di Dom Perignon, dieci candeline rosse, e due biglietti per una gita fuori porta a Kutna Hora, a un’oretta di treno dall’Hotel Nabucco di Praga. Devo premettere che noi famiglia Cailloux abbiamo sempre viaggiato parecchio e non è un vezzo se oggi mi ritengo un vampiro internazionale. Sono un francese nato in Africa, figlio unico, e mio padre Auguste (una nullità assoluta) per sfuggire alla grigia monotonia del lavoro bancario si era specializzato nel farsi trasferire da una filiale all’altra, con la scioltezza con cui una nave portarinfuse cambia porto. Ho studiato così in scuole inglesi, portoghesi e francesi. Ma in nessuno di questi mondi ho mai trovato un amico, un ragazzino che condividesse il mio mondo: l’amore per il soprannaturale e l’eccitazione sensuale per l’occulto. Ogni tanto, per fare sfoggio della mia cultura noir da autodidatta, mettevo in cartella un teschio di gatto o la pelle di una lucertola appena scuoiata. Ma le bambine strillavano di ribrezzo e i maschi facevano la spia alla maestra. A mia volta, tutte le fregole per cui sbrodolano gli adolescenti, tipo donnine nu- de e altre complesse porcheriole pornografiche, mi hanno sempre lasciato indifferente. Fateci caso, nei titoli di quelle videocassette porno che i miei compagni si scambiavano sottobanco, l’aggettivo erotico più utilizzato è «bollente». Quello che io amo di più è «gelido». Se in quest’epoca i volgari bollori sovrastano il freddo e austero buongusto, sarà mica colpa mia. In questi anni grevi la solitudine diventa una scelta obbligata. Giusto? Giusto.
La vocazione ai sacri piaceri del male la devo a mio nonno Nicholas e a un volume illustrato che mi regalò quando avevo sette anni. Una delle figure ritraeva il demone sumero Pazuzu. Fu un colpo di fulmine. Per me quel demone simboleggiava qualcosa di antico ed estremamente potente, un’icona da rispettare, come il nonno, l’unico della famiglia degno di qualche considerazione. (Il fatto che non abbia neppure accennato a mia madre la dice lunga sulla sua bollente e appiccicosa insignificanza.) Nicholas Cailloux aveva fatto la guerra d’Indocina e ucciso molti uomini. Senza tante ipocrisie, dopo una birra di troppo, mi aveva confidato che ammazzare forse non sarà saggio, ma è sicuramente bello. Per una di quelle coincidenze che fanno un destino, qualche giorno prima di partire per Praga con lui, era uscito nelle sale cinematografiche L’esorcista. Non mancai alla prima all’Arlequin, anche se dovetti intrufolarmi con uno stratagemma per via della censura. Alle prime scene rimasi folgorato come san Paolo sulla via di Damasco, alla rovescia. In un sito archeologico dell’antica città di Ninive, il prete protagonista, padre Merrin, interpretato dal vecchio Max Von Sidow, dissotterrava una statuetta che ritraeva lo stesso de- mone sumero del libro illustrato. Da quel giorno, mio nonno lo soprannominai Pazuzu. Naturalmente m’innamorai della giovanissima indemoniata, Linda Blair, tanto che la prima volta che mi masturbai, proprio a Praga, lo feci pensando a Linda seduta sul letto, che ruota la testa a 360 gradi nella stanza gelata, mentre io lecco il suo fiotto di vomito verde smeraldo.
A Kutna Hora non si respirava dall’afa, come oggi. Faceva talmente caldo che ci sembrò di star seduti sulle braci invece che sul prato verde. Proposi a nonno Nicholas di cambiare programma e consumare il pranzo di compleanno di nascosto, al fresco, in quella sinistra chiesa che si ergeva davanti a noi. Entrammo nella Cappella di tutti i Santi, al monastero cistercense. Per non farci sgridare da qualche bacchettone, ci rifugiammo nell’ossario. Per la prima volta, dopo tanto pellegrinare, ebbi la meravigliosa sensazione di essere finalmente ritornato a casa. Quarantamila teschi mi scrutavano amichevolmente dalle pareti decorate dalle loro stesse ossa. Un geniale architetto funebre aveva realizzato un’opera d’arte con i resti degli appestati di un’epidemia del 1318, trasformando la morte in una ridente stanza dei giochi. Dalle volte gotiche pendevano collane da giganti, composte di resti umani. Un lampadario regale m’illuminò la coscienza. Nonno mi spiegò che era stato fabbricato utilizzando esclusivamente tutte le ossa che compongono un corpo umano, da quelle della nuca al dito mignolo del piede. Quelle centinaia di cristalli ossei brillavano d’eternità. Era stato ideato da un certo Frantisek Rint, un intagliatore del legno trasformatosi in poeta delle ossa. Fissavo ipnotizzato quelle gocce d’avorio del lampadario, le ossa pendenti sembravano tintinnare come cristalli al vento, smossi dai ballerini di un valzer dell’Ottocento. I calici di teschi, gli stemmi d’ossa incrociate, le tibie impilate in forma di mobili pregiati, tutto era cupamente immenso. Nella mia sbrigliata fantasia infantile mi ripromisi da grande di diventare milionario e di farmi una villa in California con mobili e suppellettili umane, un letto a baldacchino tutto di vertebre ricamate una nell’altra, un materasso di soffici capelli, e lei, mia moglie, a fianco. La mia piccola, deliziosa Linda Blair. Non c’è nulla che provochi una malinconia più struggente di un sogno infantile spezzato. «E tu che farai da grande?» ci chiedevano gli adulti con quei sorrisi ipocriti di chi ha tradito se stesso. Io rispondevo: «Il vampiro». Forse non avrò mai la villa in California, però sto mettendo da parte le ossa per costruirmela.
La notte del mio ventesimo compleanno ho riprovato la stessa estasi artistica, al termine di un viaggio in Italia, in memoria di nonno Nicholas. Quella volta mi parve che le trombe e il coro umano dell’Inno alla gioia di Beethoven mi esplodessero in petto. Ero riuscito a intrufolarmi, con la mia cena al sacco, all’interno delle catacombe dei Cappuccini a Palermo. Le composizioni di quell’ossario erano meno fantasiose, la mano di quel genio siciliano meno ardita di quella dell’artista boemo, ma nella cripta dei Cappuccini c’era e c’è ancora un tesoro incommensurabile: Rosalia Lombardo, una bambina degli anni Venti imbalsamata. Ha ancora indosso il vaporoso ve- stitino di un tempo e un fiocco sgualcito nei capelli le addolcisce il visetto sbarazzino. Rosalia, che ho venerato più di Linda Blair, assomiglia in modo sorprendente alla macellaia Marguerite da piccola. Come ho premesso, nel male ci vuole stile, perseveranza, rigore, ma prima di ogni altra cosa, conoscenza. Io mi documento sempre sui miei sofferti amori. Ho quindi scoperto che la piccola macellaia di rue Lepic andava a scuola dalle suore, poco distante dalla chiesa del Sacro Cuore di Montmartre, e con una scusa ho trafugato dall’economato l’album di classe 1987-1988. Nella foto di gruppo, Marguerite è seduta in prima fila, con le gambe nude ciondoloni, il visetto cosparso di lentiggini, e un fiocco nei capelli. Oh, quel fiocco! Sono così eterne le cose, così eterne, e ci sopravvivono! Era un fiocco della stessa foggia e colore di quello sopravvissuto a Rosalia Lombardo. Quella notte, a Palermo, festeggiai il mio compleanno davanti alla bambina imbalsamata, con un piatto freddo di maccheroni alle sarde, così come a Kutna Hora avevo gustato la mia torta di ribes con nonno Nicholas, all’ombra di un lampadario d’ossa. È teneramente sadico mangiare davanti a una bambina che non può più farlo! Nelle mie fantasie erotiche, l’immagine di Rosalia polverizzò quella dell’Esorcista. Oggi, altri dieci anni dopo, mi pervade un’eccitazione immensa se penso al mio frigo nuovo abitato da una macellaia. Il Magnum sarà la gelida villa in California di una bambola con le lentiggini e i capelli rossi.
L’unico modo che conosco per non soccombere alle ingiustizie di un mondo dai valori capovolti, è quello di capo- volgere il mondo degli altri. Non è giusto che, almeno una volta, l’ultima, una macellaia prenda lo stesso posto in frigo di quello che ha riservato tutta la vita alle carni di altri esseri viventi, e grazie alle quali ha campato? Marguerite e il Magnum dovranno diventare la stessa cosa. Il massimo della femminilità e della tecnologia. Sopravvivere agli esseri umani come il fiocco eterno di Rosalia Lombardo.
Al rientro dalla vacanza per il mio decimo compleanno, mentre eravamo da soli in casa a disfare le valigie, nonno Nicholas fu colpito da un’embolia cerebrale. Rantolava che sembrava un orgasmo. Non chiamai l’ambulanza né feci nulla per aiutarlo, pur di protrarre al massimo la marcia goduriosa e trionfale della morte. Ho ucciso la mia prima vittima, molti anni dopo, per riprovare quell’orrida gioia. Purtroppo, assistere alla morte di una persona cara è imparagonabile al piacere che si prova per quella di un estraneo.
Parigi. Cimitero di Passy. 24 luglio 1988 Tra i venti e i trenta ho trascorso la maggior parte del mio tempo libero nei cimiteri. Come un botanico studia piante e fiori, così esaminavo le serrature arrugginite delle cappelle gentilizie e valutavo la pesantezza dei coperchi. Mi ero fabbricato una sofisticata chiave a L, ma se la serratura opponeva resistenza, profanavo la tomba con un piede di porco, oppure rompevo una finestra e m’introducevo da lì. A volte dipingevo Pazuzu sulle umide pareti delle cripte, a lume di candela; altre volte, al monumentale Père Lachaise, ho cenato al sacco sulla tomba di Jim Morrison dei Doors, bevuto birra accanto a Cyrano de Bergerac, fumato un sigaro con Oscar Wilde. Finché il mio «periodo contemplativo» è passato. Il 15 luglio 1988 mi alzai dal letto in preda a una sublime urgenza: disseppellire un corpo e mutilarlo. Radunai un piccolo piede di porco, un paio di tenaglie, un cacciavite, un mazzo di candele nere e dei guanti chirurgici, ficcai tutto nello zaino da picnic e presi il métro. A mezzogiorno i cancelli del cimitero di Passy erano spalancati, ma i becchini e gli impresari di pompe funebri stavano gozzovigliando al ristorante. Passy è un piccolo cimitero gotico del XIX secolo, situato in mezzo a due grandi arterie molto trafficate: impossibile profanarlo di notte. E chi si sarebbe mai potuto immaginare che qualcuno lo profanasse all’ora di pranzo? Di vampiro in Francia ce n’è uno. Giusto? Giusto. Ero io, anche se ancora non sapevo di esserlo. Una tomba mi ronzava nella mente. La cappella di una famiglia di profughi polacchi. Giorni prima avevo assistito, in disparte, al funerale di una bambina, e mi era parso che il corteo di familiari l’avesse accompagnata lì. In chiesa, purtroppo, uno dei suoi mi aveva notato, e in parecchi si erano girati verso il confessionale dietro al quale mi ero appostato. Così ero stato costretto a tagliare la corda e ad assistere alla tumulazione da troppo distante per avere la matematica certezza che la cappella giusta fosse proprio quella dei russi. Avevo già ficcato il naso nella porta di ferro, la sera prima, scardinando la serratura, poi l’avevo camuffata in modo che apparisse intatta. La visione delle scale di marmo che scendevano a precipizio nelle viscere buie di un’antica famiglia di Varsavia mi aveva travolto d’eccitazione. Tutto quel che dovevo fare, adesso, era sferrare un calcio alla porta. Si aprì con uno schianto, sentii un cane abbaiare in lontananza, poi più nulla. Mi barricai nel mio nuovo regno, e sussurrai ai sudditi dormienti nei sotterranei, e soprattutto alla bambina: «È arrivato il Principe!». Avevo la coscienza in caos. Io lo chiamo «l’orgasmo nero », è un dono e una condanna. Come Beethoven che, da sordo, era costretto a dirigere l’orchestra percependo nient’altro che un fragore indistinto, così io vengo travolto da un’immoralità tumultuosa, un’energia che mi sbatte all’infuori di me con violente mareggiate, tutte le volte che mi accosto al piacere supremo. Cercai di dominarmi. Accesi una candela nera e iniziai a discendere cauto le scale. A ogni gradino, un flash di morte m’incendiava il cervello. Era come se avessi avuto tutti i nervi illuminati. Il feretro della bambina occupava la posizione centrale. La bara, di quercia solida, era sigillata con viti cromate. Mi parve nuova di zecca, anche se di eccessive dimensioni per una donna in miniatura. Per «sbottonare» tutte quelle viti impiegai quasi un quarto d’ora. Ero eccitato, pensavo al fiocco di Rosalia, la bimba imbalsamata, ai suoi riccioli sulla fronte simili alle virgole di burro che i camerieri dei ristoranti ti propongono per ingannare l’attesa del primo. Non vedevo l’ora, anche se non sapevo bene di che. Deglutendo dall’eccitazione, e rivolgendomi io stesso la domanda, mi risposi: di mangiarmela e bermela. Non sapevo neppure io che cosa stessi dicendo, ma il risultato fu che mi bagnai, come quando mio nonno rantolava sul parquet, fra le valigie vuote e spalancate come bare in attesa. Quella volta avevo temuto di essere omosessuale, invece mi ero eccitato per la morte in sé, non per un maschio che muore. La morte non ha sesso, come gli angeli. In preda alla frenesia, feci saltare l’ultima vite con un pugno sul cofano della bara, e la scoperchiai con il piede di porco. Finalmente vidi il corpo dentro. Che delusione! Non era la piccola polacca che avevo tanto sperato, ma una vecchia signora mezza ammuffita, avvolta in un sudario grigio, insozzato di macchie marroni. Il suo viso sembrava spalmato d’olio solare, erano i fluidi della morte che trasudavano dalla pelle. Il lezzo di Thanatyl, il prodotto che gli imbalsamatori utilizzano per ritardare la decomposizione, era intollerabile. Tentai di sollevare un lembo del velo, ma era appiccicato all’incarnato di pietra. Allora lo squarciai con il cacciavite. I denti sporgevano ancora dalla bocca, ma gli occhi erano andati. Mi curvai come un biologo sul microscopio, quasi volessi introdurmi nelle orbite oculari vuote, e d’un tratto fu come se una mano mi afferrasse da dentro quel guscio decrepito di donna, scaraventandomi nelle galassie. Vidi grappoli di cosmi e di nebbie stellari che mi attraversavano, mentre deragliavo a folle velocità nell’universo, e sentivo il mio corpo scagliato nello spazio congelarsi ai raggi di soli freddi e sconosciuti. Quella vecchia mi stava attirando nella sua trappola immortale. Sta uccidendomi con la sua stessa morte! pensai in quel turbinio, e per ribellarmi infersi il primo colpo di cacciavite nel cuscino di raso del cadavere. Il corpo all’interno della bara si mosse leggermente, come avesse intuito che cosa stava per accadergli. Così iniziai a pugnalarle dapprima la pancia, poi l’area costale e le spalle. Credo che la trafissi almeno cinquanta volte con la furia di un demone. Ero posseduto come Linda Blair, ma da Pazuzu, e nessun esorcismo avrebbe mai potuto fermarmi. Ricordo che a un certo punto la sollevai, ma non sapevo più che parte del corpo fosse, scaraventai quel blocco rancido in un angolo della cripta, e persi conoscenza. Quando mi svegliai, i miei avambracci erano ricoperti di melma del cadavere. Mi ero afflosciato di traverso nella bara, sfinito ma felice.
Parigi, 11 agosto 2009, le cinque della sera Ce l’ho fatta, le ho rivolto la parola con eleganza disinvolta, la macellaia dai capelli rossi non vedeva l’ora di chiacchierare con qualcuno. Ormai sento che oggi sarà una data da Calendario del Male. L’intuizione beethoveniana è stata quella di riaffacciarmi a Montmartre di sera, quando tutto è più fresco e le difese delle donne si abbassano. Entrando alla macelleria Roger mi è parso, addirittura, che i suoi meravigliosi seni mi abbiano fatto un inchino. Ho comprato una bistecca di cavallo, anche se avrei voluto ritagliarla personalmente dalle sue cosce bianche. Infatti le ho chiesto con disinvoltura un autorevole parere professionale: «Secondo lei, quanto tempo devo lasciar macerare la carne in frigo prima di cucinarla?». Naturalmente intendevo carne umana, ma non potevo certo dirglielo. Sulle prime Marguerite non ha capito, così ho dovuto specificarle: «Mi riferisco al miglior sapore delle carni. È meglio gustarle subito, o dopo due o tre giorni?». Mi ha sorriso, è sembrato che il cielo mi facesse l’occhiolino. Con le mani sui fianchi, e un’arietta da macellaia prima della classe, ha detto: «Considerato che le mie carni sono assolutamente freschissime» (ho annuito pensando ai suoi seni e alle sue cosce) «direi che fra tre giorni è l’ideale». Tre? Ho fatto il segno con le dita. Lei ha riso e mi ha risposto allo stesso modo, sollevando il braccio destro come la Statua della Libertà. Mi ha fatto letteralmente impazzire perché ho scoperto che non si rade. Le ragazze degli anni Cinquanta non si radevano, l’ho visto nei film. Le donne di oggi ignorano quanto siano deliziose quelle piccole caverne di peli arruffati! Quanto vorrei ritagliarmi le sue ascelle e portarmele a spasso nelle tasche, una di qua l’altra di là, le userei come portamonete. Borsellini di donna, andrebbero a ruba. Per noi maschi sarebbero un delizioso e vendicativo accessorio. Quanti soldi ci portano via le donne? Che almeno ce li portino loro, una volta tanto, nascosti nelle ascelle! Giusto? Giusto. Marguerite ha capito benissimo che ci stavo provando, anche se ignora l’assoluta potenza distruttrice del mio amore. Ci siamo bevuti un caffè al Bar des 2 Moulins, qui in rue Lepic, ma non ha acconsentito a darmi il numero del cellulare. Le ho sorriso con elegante noncuranza, e questo eccita le femmine; a loro piace essere strapazzate, nonno Nicholas me lo rammentava sempre. Così le ho detto che «Può darsi» sarei ripassato un giorno o l’altro, mentre dentro di me mi ripromettevo di noleggiare una limousine per fare più scena possibile. Farò spuntare davanti alle vetrine della Macelleria Roger il suo lungo e sfavillante muso nero, un minuto prima dell’ora di chiusura. Monterai in macchina con me, piccola Marguerite dal fiocco di burro? Tu sopravviverai al mondo, amore mio, vedrai, il mio Magnum nuovo sarà la tua cripta dei Cappuccini di Palermo, la tua villa a Malibu, il tuo scrigno perfetto. E per berti e mangiarti attenderò tre giorni, esattamente come mi hai consigliato tu.
Istituto di medicina legale di Parigi. 1° dicembre 1993 Questa è la penultima data che mi riguarda nel Calendario del Male. Il giorno in cui ho scoperto di essere un vampiro, e anche qualcosa di più. Stiamo parlando di sedici anni fa, da allora non ho mai smesso, tranne per il digiuno forzato in carcere. Nell’inverno del 1993 riuscii a farmi assumere all’Istituto di medicina legale di Parigi come inserviente d’obitorio. Il mio compito era quello di dare una mano durante le autopsie, pulire i tavoli e preparare i corpi per la camera ardente. Da quel giorno la magnifica collezione di reperti macabri, che imbellisce il mio salotto, ha cominciato ad arricchirsi vertiginosamente di pezzi unici. Ancora rido se penso alla faccia degli investigatori del Dipartimento criminale quando irruppero nel mio appartamento, al 19 di Faubourg Saint Honoré. Frammenti di ossa e denti umani erano sparsi come spiccioli in tutta casa. Vertebre e ossa di gambe penzolavano dal soffitto, compreso un lampadario di tibie, un po’ naif, l’ammetto, non ho l’estro artigianale di un Frantisek Rint, l’intagliatore di Kutna Hora. E poi le mie «aranciate», le sacche di sangue in frigorifero, e le centinaia di nastri sadomaso, le videocassette amatoriali dei miei amori imbalsamati, e naturalmente la collezione che amavo di più e che quei coglioni di poliziotti mi sequestrarono e allungarono a qualche prete per disperderla nel vento: centocinquanta barattoli di ceneri umane. Tutto questo bendiddio cominciai a trafugarlo nelle sale autoptiche, fino al brutto giorno in cui il direttore dell’istituto mi beccò mentre staccavo i denti a una defunta. Credendo che fosse un episodio isolato, e convinto che l’avessi fatto per rubare un dente d’oro, non mi denunciò ma mi fece licenziare. Il 1993, tuttavia, è stato il mio anno fortunato. Quindici giorni dopo mi assunsero alla clinica universitaria del Sacré-Coeur, unità di chirurgia d’urgenza. Una delle mie mansioni era quella di trasportare sacche di rosso nettare dalla banca del sangue dell’ospedale alle sale operatorie. Trafugai la prima, e fu il mio battesimo. La sorseggiai cautamente dopo averla refrigerata a dovere nel mio vecchio frigo della Zoppas e aver shakerato il sangue con proteine in polvere, ceneri umane e ghiaccio. Questo cocktail l’inventai per necessità. Nelle buste non c’era plasma, quindi il sangue era troppo liquido, scelsi di addensarlo un po’. Sui gusti non si discute. Giusto? Giusto.
All’Istituto di medicina legale, alcune autopsie le lasciavano fare direttamente a me, anche se ero un modesto assistente. Ma sono sempre stato un lavoratore impeccabile ed è estremamente raro trovare un assistente d’obitorio così innamorato del proprio mestiere. Facevo l’incisione a Y, tagliavo le costole alle giunture, aprivo il teschio con la sega elettrica. Il patologo si limitava a dissezionare gli organi e a inserirli nei contenitori. La gran parte delle volte mi lasciavano da solo con il corpo, dopo l’autopsia, per fare le suture, che erano la mia specialità. Il 1° dicembre, nell’anniversario di ma- trimonio dei miei genitori, entrambi defunti, feci il penultimo grande passo. Tagliai una strisciolina di muscolo dal corpo di un’aitante ventenne uccisa da un collega, anche se il termine è inesatto, poiché si trattava di un banale violentatore. Me la portai a casa e me la cucinai fritta. Era dolce, gustosa, davvero eccellente. Da quel giorno divenni insaziabile, perché una volta attraversato il confine di un vizio nuovo, tornare indietro è pressoché impossibile, e la potenza che t’infonde la carne umana è imparagonabile a qualsiasi cibo. Per questo è proibita. Perché è buonissima. Ti sembra di toccare la faccia di Dio. Ti fa sentire come se non appartenessi più alla razza umana. Ricordo che con calligrafia tremante, prima d’addormentarmi, scrissi sul diario: «Wow! Ora sono un cannibale. Fico!».
Parigi, 18 ottobre 1994 Questa giornata, sul Calendario del Male, non può avere altri riferimenti storici che il mio. È la malignissima ricorrenza della mia vita, e nonostante mi sia costata qualche anno di galera, il 18 ottobre del 1994 lo posso paragonare al fatidico giorno in cui Beethoven sedette al pianoforte e trovò il primo accordo dell’Eroica. Io suonai per la prima volta quella sinfonia del male supremo che s’intitola Omicidio. Quel giorno mi sentii come un turista occidentale stremato dopo una vacanza interminabile nei paesi asiatici, con lo stomaco sottosopra per tutte le schifezze che ha dovuto ingerire in trattorie dai nomi improbabili, che finalmente, nella cucina di casa sua, si prepara il suo piatto preferito. Io, fino a quel momento, che male avevo fatto, in fondo? Profanato qualche mausoleo, sorseggiato qualche litro d’aranciata umana, collezionato ricordi, e arrostito qualche chilo di carni bianche, condite al ragù e tagliate a striscioline come tagliatelle alla bolognese. Dovevo alzare l’asticella al massimo. Uccidere un uomo. Giusto? Giusto. (Anche Pazuzu era d’accordo.)
Trascrivo parola per parola quel che dichiarai agli inquirenti poco dopo che i poliziotti mi acciuffarono, proprio qui a Montmartre, sulla soglia del Moulin Rouge. (Dalle dichiarazioni di Jeremiah Cailloux rese al pubblico ministero dottor Lapointe il 27 ottobre 1994) […] quanto all’omicidio che mi viene attribuito, quello di Roger Demain, tutto è iniziato in un bar, uno di quei locali frequentati da gay dove tutti sono gentili e nessuno fa troppe domande. Mi avvicinai a Roger, che stava seduto solo al bancone, e sfoderai il mio sorriso più convincente. Era un giovane uomo dall’aspetto piacevole, curato nell’abbigliamento, ma a me importava poco, perché con lui avevo altri progetti che una notte di sesso. Mi invitò a casa sua, ma non mi sentivo ancora pronto, così ci mettemmo d’accordo per vederci la sera dopo, sempre da lui. Sembrava felice quando mi aprì la porta, senza notare la pistola che avevo infilata nei pantaloni. Entrai velocemente, e mentre stava richiudendo estrassi la pistola. Dopo un istante d’impaccio premetti il grilletto. Gli sparai in un occhio. Cadde istantaneamente a faccia in giù senza una parola. L’osservai sanguinare sul tappeto. Poi decisi di dare un’occhiata al suo appartamento. Non era niente di che, roba da poveracci, e quando ritornai in salotto Roger si muoveva ancora. Ricaricai e sparai ancora, questa volta colpendolo alla nuca, poi ancora, la terza e ultima volta, alla schiena. E finalmente la smise di frignare. Al magistrato, ovviamente, non raccontai proprio tutto. Per esempio, che mentre lui rantolava a terra, come nonno Nicholas, io mi ero toccato. ça va sans dire. Giusto? Giusto.
Parigi, 10 agosto 2009, ora di cena Sono stato scarcerato per buona condotta. Da allora, finalmente, mangio carne umana e bevo sangue come un tempo, ma devo farlo sempre di soppiatto e accontentandomi di vecchi avanzi di cimitero. Ma stasera no. Stasera riassaporerò il mio orgasmo nero. Oggi, 10 agosto, ormai è certo, sarà inserito a cubitali lettere nere nel Calendario del Male. Ma per sapere davvero come andrà a finire, dovrete aspettare la sua pubblicazione. E comprarvelo. Voi giudici non avete idea di cosa sia un vampiro, miserabili, voi che bevete acqua, quanto tempo potete resistere senza? Anche in questo vi sono superiore. Ho resistito sette anni fino a convincervi di essere innocuo. So digiunare, so meditare, so aspettare. Sono il Siddharta rovesciato. Che cosa vi credete? Bene e male sono composti dalle stesse qualità. È solo l’uso che se ne fa che è diverso. Un paio d’ore fa ho noleggiato questa splendida limousine francese (lo stesso nome di un famoso taglio di carne, non è buffo?), una Citroën Cx Prestige, da nababbi, persino troppo per la mia piccola macellaia. Appena l’ha vista ci si è quasi tuffata dentro.
Ora però devo chiudere questi appunti mentali per il mio Calendario del Male. Nel mio lavoro, il rigore prima di tutto. Devo concentrarmi sull’obiettivo: la carne più sexy e profumata di Montmartre. Ho fatto tutto in fretta e furia. Sono rientrato a casa appena in tempo per ricevere il mio nuovo Magnum e farmi una doccia. Sono riuscito a razzo, ho noleggiato la Prestige e sono apparso in pompa magna in rue Lepic, nel preciso istante in cui Marguerite stava abbassando le saracinesche.
Adesso stiamo scendendo dalla collina di Montmartre, la mia Spoon River, e mentre guido taciturno tu mi guardi trasognata, come fai da sola, alla Macelleria Roger, fissando gli abbaini dove la vita umana scorre, oltre le vetrine del tuo camposanto degli animali. Certamente ti starai domandando che lavoro faccio per permettermi tutto questo lusso. Avrai già l’acquolina in bocca come me, ma per opposte ragioni. «Che lavoro fai?» Me l’aspettavo. L’hai chiesto. Taccio per farti rosicare. Alle donne piace essere strapazzate, giusto nonno? Giusto. «E dai, Jeremy, che lavoro fai? L’agente segreto?» Il vampiro, amore. Ma seguirò il tuo consiglio. Ti attenderò tre giorni prima di berti e mangiarti tutta. Nel frattempo praticherò un foro nel mio Magnum, per spiarti dal buco della serratura. Soprattutto questi piccoli dirigibili, queste tue morbide bottiglie di latte che già ti stai lasciando accarezzare. Puttana. Li intaglierò a forma di lampadario. Appenderò i tuoi seni al soffitto, piccola Marguerite, come nella cripta di Kutna Hora. Ci metterò una lampadina dentro. Una per questa qui, e una lampadina per quest’altra. Ti piace farti toccare, eh? Sei più puttana di mia madre. Farò un lavoro di fino. Da imbalsamatore di una volta. E quando mi mancherai (perché mi mancherai, Marguerite, come Linda Blair, nonno Nicholas e Rosalia, la piccola imbalsamata di Palermo) allora mi fumerò la pipa seduto in poltrona, al buio. Poi accenderò i tuoi seni che brilleranno al soffitto, sfavillanti e infiniti come stelle, e come tutte le cose belle che ci sopravvivono.
(Tratto dall’antologia “Tre metri sottoterra” -Cairo Editore-)
- Le apparizioni di Gesù risorto - 20 Febbraio 2017
- Un vizio capitale: l’invidia - 6 Febbraio 2017
- La melodia dell’amore - 30 Gennaio 2017