di Enzo Buscemi
Più che in campagna, dove non era affar nostro, i preparativi per la vendemmia cominciavano, qualche giorno prima, nel nostro palazzotto, antico della prima metà del Trecento, sulla piazza Duomo di Castroreale.
Soprattutto in cucina.
Donna Ciccia, da molti lustri al vertice del personale di servizio, dava disposizioni secche. Decidendo da sé, visto che i miei nonni, ai quali la nostra grande famiglia faceva capo, quando da Messina tornavano in paese, le demandavano, con piacere, la maggior parte delle operazioni relative all’andamento della grande casa.
Il menù, per quanto possa ricordare, aveva alcuni piatti tradizionalmente ripetitivi. Altri, erano ogni anno diversi. Così, all’attico, nella cucina, enorme, con una lunga fuga di fornelli, tutta in mattonelle di ceramica a disegni blu, e con una serie di splendenti pentole di rame battuto a mano, appese alle pareti, sino al soffitto, per primi, nascevano i sughi.
A seconda del menù cuocevano a fuoco lentissimo (“come su un fiammifero” raccomandava mia nonna), lo stufato o il profumatissimo ‘aggrassato’ ovvero quello che nel resto del mondo chiamano ‘arrosto’. Termine che, invece, in Sicilia, identifica la bistecca alla piastra, con i prevedibili e gustosi equivoci, quando i siculi, con educazione tradizionale, lo scelgono sulla carta dei ristoranti del nord.
Il sugo di stufato serviva a insaporire i ‘falsomagri’. Sorta di sottili bistecche arrotolate intorno a uova sode, formaggio fresco, pan grattato, salame, e il tutto aromatizzato con generose manciate di pepe nero.
Legati strettamente con il sottile spago da ciabattino, erano prima ‘rosolati’ in un tegame, dove, poi, li annegava il profumatissimo sugo.
L’‘aggrassato’ era, invece, il taglio internazionale da arrosto, cotto anch’esso su un fiammifero, su un letto di cipolle tagliate come ostie, una serie di altri aromi, latte, e forse vino bianco secco.
Se poi si optava per un primo piatto, da accoppiare a quello che i nostri coloni preparavano nelle varie palazzine di campagna, aperte per l’occasione, la scelta cadeva, quasi sempre, sulla pasta al forno. Un pasticcio tanto profumato da far girare la testa. Frutto di pasta, rigorosamente corta, sugo e sottilissimi tranci di stufato, formaggio di almeno tre tipi e di stagionature diverse, salame piccante, uova sode, melanzane (fritte in precedenza), piselli e altri ingredienti, che adesso mi appaiono in sovrannumero ma che, a quei tempi, sinceramente adoravo.
I dolciumi, ordinati a Nunzio Freni, il pasticciere di famiglia, di solito erano in grande quantità, poiché a quei tempi i lavoratori dei campi (detti appunto coloni, alla sicula, o contadini), avevano nidiate di figlioli di età molto varia ai quali quelle leccornie erano principalmente destinate.
Il vino non si portava mai da casa. Nelle palazzine di campagna c’erano sempre piccole botti. Dopo ogni vendemmia, il contenuto veniva rabboccato con il vino della nuova produzione.
Il risultato, a quanto ascoltavo dalle impressioni dei commensali, soprattutto amici di famiglia o visitatori estemporanei, pare fosse sensazionale.
Al pane, pensavano i contadini che ne preparavano una ‘fornata’ apposta per la ricorrenza. Era impastato con farina bionda, di grano duro e fragrante olio d’oliva. Il tutto, in seguito, il campiere (sorta di amministratore bucolico), si occupava a ripagare molto generosamente su precise istruzioni di mio nonno.
bucolico), si occupava a ripagare molto generosamente su precise istruzioni di mio nonno.
Le località di vendemmia erano almeno tre. La quarta e la quinta non amavamo frequentarle mai.
Quindi, le mete abituali erano nell’ordine: Brafalè, in bassa collina, sede delle attrezzature di produzione, e fonte di un vino rosso da brivido.
‘Mortilli’, sul degradare da mezza costa verso il mare (lungo gli argini di un torrente dal letto sterminato). Ospitava un vigneto di pregiate uve bianche per un ‘bianco’ di altissima gradazione. E inoltre, uno sterminato agrumeto che proteggeva dal sole cocente un tappeto di saporiti ortaggi. Una coltura preziosa per il contributo di una adoratissima sorgente d’acqua cristallina.
E, infine ‘A girasara’, un piccolo podere in collina, con viti da nero profumato di ciliegia (girasa) e pesca, curato dal Pulicitto (piccola pulce) soprannome del nostro capo colono. Un simpatico mangiatore di incredibili quantità di peperoncini che arrostiva sulla brace, e accompagnava a bocconi di pane, calibrati uno ad uno, con un affilato serramanico.
Qualunque fosse la destinazione, il rito di partenza era sempre simile.
Si vendemmiava in giorni diversi. Circa tre per ogni podere, dall’alba sino a sera. Noi, di ogni località frequentavamo solo la prima giornata.
Svegliati di buon’ora, trovavamo vettovaglie e biancheria da tavola, custodite in grandi valigie di pelle, già sul tetto dell’automobile, il baule interno non esisteva ancora. La vettura era pronta davanti al grande portone che si apriva sul corso di Castroreale o, certe volte, dalla parte opposta del palazzo, nella stradina che portava all’ingresso delle ex scuderie, ormai grande anticamera delle capaci cantine sotterranee.
Non ci restava che prendere posto sui cuscini di morbido panno e lasciare che l’automobile partisse con il caratteristico lamento dei motori dell’epoca.
A me toccava di rigore la poltrona anteriore, nei primi anni sulle ginocchia di mamma, poi da solo.
Da piccolo, e anche in seguito, ho sofferto il mal d’auto. E, benché sulle quattro ruote avessi trascorso gran parte dei miei giovanissimi anni, ogni volta il sacrificio mi costava molto.
Ovviamente, alla vendemmia intervenivano anche i nonni (ho conosciuto solo quelli materni), e certe volte, il resto della famiglia, che viveva a Messina, con zie e cugini più piccoli.
Il viaggio era breve. La maestosa Bianchi S9, color crema con i grandi parafanghi verde scuro, e portafiori ai lati dei sedili posteriori, passava ondeggiando da una buca all’altra, sulle strade, ancora bianche, che portavano alle mete. E, all’occorrenza, ripeteva il tragitto diverse volte.
All’arrivo, la consueta accoglienza festosa delle mogli dei contadini, attorniate dalla vociante truppa dei bambini, coperti alla meno peggio da abiti ricavati da chissà quali reperti di anni precedenti e, per questo, variopinti per i rattoppi di stoffe di altro colore che, in pratica, avevano annullato il tessuto originale.
A Brafalè e a Mortilli, c’erano palazzine padronali del tardo Settecento. In occasione della vendemmia, erano già state aperte e rinfrescate. Sui tavoli, negli antichi vasi di ceramica, ci accoglievano fiori, freschi di campo.
Ricordo una delle tante vendemmie a Brafalè. Località che preferivo per vari motivi. Ma soprattutto poiché la trasferta era più breve e il mal d’auto, sopportabile.
Il tempo di cambiare le scarpe, ed ero subito tra le vigne, dove una turba di donne staccava i grappoli dalle piante, con coltelli con la lama quasi scomparsa a via di affilarla. Li lanciavano con maestria, in grosse gerle foderate di tela cerata, ad evitare che il succo ne filtrasse, quando se le issavano, in mirabile equilibrio, sul capo, poggiandole su uno strofinaccio arrotolato.
Poi, così gravate, ma sempre con movimenti eleganti, si dirigevano al ‘palmento’.
La ‘fabbrica’ del mosto era strutturata in modo che l’uva si potesse scaricare nella vasca di pigiatura, direttamente da un’ampia finestra, dall’esterno.
Stupendo, osservare la cascata di grappoli (solitamente neri a Brafalè e bianchi a Mortilli), arrivare ai quattro o cinque contadini che dovevano pigiarla. Percorrevano spirali perfette e poi concentriche, sin dai bordi della vasca, perché ogni acino fosse spremuto a dovere.
Gli ‘uomini ‘ (venivano genericamente chiamati solo così), pigiavano a piedi nudi, con i calzoni rimboccati sopra il ginocchio. Ognuno teneva la mano appoggiata sulla spalla di chi lo precedeva. Alla stregua dei detenuti delle carceri francesi, in fila obbligata nella passeggiata dell’ora d’aria. E cantavano.
Ad ogni nuovo contributo di grappoli, gli ‘uomini’ aggredivano la piccola montagna succosa per schiacciarla. Con passi pesanti, ne ottenevano copiosi rivoli di mosto che affluivano a un grande tino, sotto la vasca, semicoperto da grandi tavole, ormai più zuccherose del succo che proteggevano.
Ad evitare che nemmeno una sola buccia cadesse nel mosto, provvedeva un grosso paniere, appeso a mo’ di filtro, alla canna di scarico della vasca di pigiatura.
Tutto per limitare l’eccessiva contaminazione del succo, con il tannino delle bucce. Antica raffinatezza che, al contrario, in altre regioni gli enologi delle cantine più famose ignorano con cura, per dare più corpo al loro vino.
Osservata per un po’ la pigiatura, passavo a riscoprire, come ogni anno, gli angoli più remoti della nostra palazzina. Frugavo nella misteriosa cantina tra ceste ormai vuote, e mi estasiavo davanti a vecchie riviste del Touring club, trasferite regolarmente dal nonno, scoprendo paesaggi e città ancora sconosciuti.
Il pranzo, alla lunga tavola, apparecchiata con le stesse posate d’argento che usavamo quotidianamente a casa, e con una delle solite, belle tovaglie di Fiandra, traforata da elaborati ricami, era un rito.
Eravamo in tanti, e le mogli dei contadini aiutavano donna Ciccia e Nata, la più affidabile delle altre donne di servizio, a scaldare le vivande e a portarle in tavola.
Prima della pasta al forno (che ogni anno passava pressoché intatta ai contadini) ci servivano un incredibile minestrone fatto da Luigia, moglie di Carmelo, capo dei coloni, con la ‘fagiola pasta’ (baccelli grossi e profumati), patate, pomodori, altri ortaggi, sedano e basilico in quantità, a condire lo ‘spaghetto pirciato’.
Se ben ricordo, sorta di bucatini ‘sudisti’ che venivano però spezzettati. Il tutto insaporito dal nostro profumatissimo, ‘illibato’, olio d’oliva e imbiancato di pecorino piccante.
Poi veniva il resto. I vini erano quelli dei diversi poderi, fino a un bianco di ‘zibibbo’, servito a fine pasto, con i dolci.
Io, allora, non bevevo nulla di alcolico. Sciaguratamente, avrei imparato a gustare il vino e non certo di sincera qualità, solo molti anni più tardi, nelle trattorie toscane, che frequentavo a Milano.
Allora, invece, pasteggiavo con grandi bicchieri di acqua ‘ruggiata’. Dove quest’ultimo termine, ai più incomprensibile, identificava un’acqua, ferruginosa, donata da una sorgente poco lontana. Sapeva proprio di ferro, e ne lasciava tracce evidenti al suo passaggio, lasciando la fonte. Bastava aggiungerle qualche goccia di limone, per farla, clamorosamente, effervescente.
Il pranzo durava a lungo, perché alla famiglia, già di per sé numerosa, quasi sempre, si aggiungevano amici vari. Si parlava.
O meglio. I ‘grandi’ parlavano parecchio.
Dopo pranzo, ospitati dalle poltrone di vimini ammorbidite da cuscini, che erano gran parte dell’arredamento della palazzina di campagna, quando i nonni e le zie erano a riposare al piano di sopra, ognuno recitava le sue barzellette che io, regolarmente, non capivo. Per questo, stufo di fare tappezzeria, andavo su per la collina, spesso accompagnato dal cane da guardia dei coloni, che sin dal mio arrivo avevo colmato di attenzioni dandogli quanto, di solito, non gli capitava di mangiare in un’intera settimana.
Passavo dal vigneto fino al boschetto di peschi e salivo ancora. Di terrazza in terrazza, fino alla sommità della collinetta, costellata di ciuffi di canne, ondeggianti nel vento fresco che arrivava dal mare.
Solo con me stesso, ricostruivo certe situazioni apprese dalle mie prime letture, regolarmente assimilate con bramosia.
Allora, e per diversi anni ancora, sarei stato affascinato da Salgari. Da lui scoprivo l’Oriente, e apprendevo ogni sfumatura di quei Paesi e delle loro misteriose civiltà.
Sapevo tutto delle dinastie cinesi, delle caste indiane, di certi crudeli riti religiosi e dei fachiri, che si lasciavano germogliare piantine nella carne del palmo di una mano.
E sulla cresta della collina di Brafalè rivivevo, in mezzo alle canne piumate, le avventure di Tremalnaik, di Sandokan, la tigre della Malesia, e del suo inseparabile Yanez.
E impartivo ordini a Sambigliong, il fedele nostromo, mentre Darma, la tigre reale di Tremalnaik (avevo così nobilitato l’affettuoso cane di turno), mi seguiva a proteggermi dagli affilati kriss dei Thugs del crudele Suyodana.
Immaginavo di essere uno di quei personaggi e altri ancora. All’occorrenza, uscendo e rientrando nei panni di ognuno, dandogli voce, senza sbagliare una virgola, nell’economia della vicenda che sceneggiavo di volta in volta.
Ripetevo, a memoria, i dialoghi imparati naturalmente e con passione sui miei libri favolosi. Ma, ovviamente, in silenzio, senza mai proferire una sola parola, visto che agivo da solo.
Spesso inventavo nuovi dialoghi, esclusivi con me stesso, mentre cambiavo personaggio.
Sempre in silenzio, tranne che per chiamare la domestica versione della tigre Darma.
E, a un certo punto, scendevo dall’altro versante della collina, sino al torrente, sul fondo della piccola valle, dove sorgeva il nostro frantoio, circondato da profumatissimi tigli e da gelsi secolari.
Nelle acque limpide del torrente, immaginavo di ormeggiare il mio praho. La mitica imbarcazione dei pirati malesi, e mi avviavo verso nuove avventure.
In mezzo a quegli alberi che spacciavo per improbabili Baobab, mi figuravo udienze reali, feste e battaglie.
E giravo intorno al nostro antico frantoio, che di anno in anno diventava il Tahjmaal o il palazzo del salgariano bramino dell’Assam, che in una crisi di follia aveva sterminato tutta la sua famiglia.
Ma io, implacabile, alla fine, lo uccidevo.
Ed ero esaltato, come non mai.
Il mondo magico delle mie letture mi coinvolgeva in vicende sempre diverse e affascinanti, per foreste intricate e per mari, spesso assai tempestosi ma, per me e per i miei eroi, sempre facilmente navigabili.
E, accelerando il tempo, magicamente condensavo vite intere e le concludevo, in poche ore.
I miei anni, inferiori a due lustri, si allungavano a volontà. E io cambiavo età con ogni personaggio.
Così, spesso invecchiavo, guadagnandomi la saggezza di una maturità assolutamente sconosciuta, e che sarebbe arrivata tanto più tardi con l’irrinunciabile invecchiamento. Allora ‘incautamente’ auspicato e che poi, con l’esperienza, avrei, inutilmente, rimandato.
Di vita in vita, il sole calava.
Protagonisti morivano, altri ne arrivavano giovani, belli, e pieni di risorse al limite della divinità, fino a quando, a rompere il viaggio siderale, venivano a cercarmi i figli dei nostri coloni.
Lasciavo sempre a malincuore le rive del sacro Gange e abbandonavo il praho nella caletta che avevo appena inventato, vicino al ruscello.
Salutavo le lucertole, già spacciate per coccodrilli, e rientravo.
A quel punto mi toccava il rito del lavaggio. A base di cascate, da grandi boccali, di acqua tiepida.
Lo gestiva donna Ciccia. L’unica col privilegio di vedermi nudo, insieme a mamma, che mi rivestiva con biancheria e abiti puliti e poi dava l’immancabile tocco della scriminatura, ai miei biondissimi capelli.
‘’Li hai lunghi, domani chiamiamo Bernardo‘’, interveniva regolarmente mio nonno, ammiccando con i suoi grandi occhi celesti.
E sapevo che non sarei sfuggito al figaro che, ogni mattina, veniva a raderlo nello studio, con le pareti tappezzate da grandi librerie traboccanti di volumi pregiati. E intanto il nonno, accomodato su una autentica poltrona, professionale, da barbiere, in legno lucidissimo, leggeva La Tribuna del mezzogiorno, allora unico quotidiano di Messina.
Non sopportavo Bernardo. Mi costringeva a stare con la testa innaturalmente piegata in avanti, fino a intorpidirmi i muscoli del collo.
Per fortuna, qualche volta interveniva papà a salvarmi: “No, non tagliarli troppo’’, consigliava con un tono cortese ma che non ammetteva repliche ‘’non farlo somigliare a un militare. Mio figlio sta bene con i capelli un poco lunghi’’.
Io, riconoscente, lo gratificavo con un sorriso e, finalmente la mano, sempre gelida, di Bernardo, allentava la pressione.
La macchinetta tagliacapelli tornava sulla mensola sotto lo specchio, e il fastidio cessava.
Dove ero rimasto? Sì, alla scriminatura.
Momento conclusivo dei giorni della vendemmia che, per noi, in quel podere, era terminata.
Per i braccianti, invece, sarebbe andata avanti per altri due giorni.
Io, in quella data, sarei andato nell’altra tenuta, a Mortilli.
Quella che finiva vicino al mare, a Marchesana, dove trascorrevamo ogni estate.
Ma che dico?
Sull’Oceano Indiano.
Davanti all’isola di Mompracem, il regno della tigre della Malesia.
E su quella spiaggia, ne ero certo, avrei trovato Marianna, la bellissima ‘perla di Labuan’, ad aspettarmi.
Roma, 1997

- La quale… [parte II] - 26 Maggio 2025
- La quale… [parte I] - 26 Maggio 2025
- La terra della talpa - 20 Maggio 2025
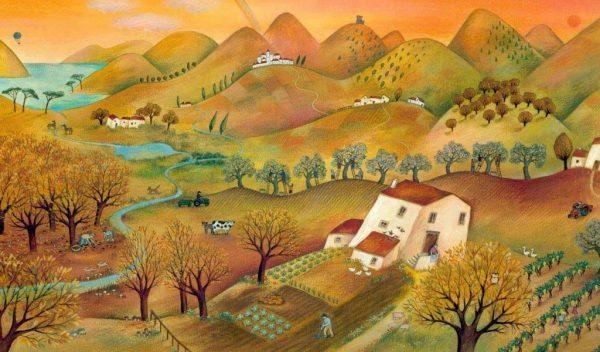





Dipinto meraviglioso, con uso di pennellate d’olio dai colori forti e densi. Il territorio che ci ha visti bambini,il rito di una vendemmia che rivive nella memoria e che si ripete periodicamente, portandoci ,intatti, profumi ed episodi di un’età ormai passata, ma che suscita emozioni limpide e profonde come le gioie della fanciullezza.Grazie Enzo, è piacevole rituffarsi nel passato, grazie ai tuo racconti ricchi di particolari e di dolci rimembranze.Alla prossima!
Un abbraccio !
Lucia Contino
Gent.ma Lucia,
riferiremo il Suo commento a Enzo Buscemi, cui certamente sarà gradito.
Grazie anche da parte della Redazione di LM.
Un cordiale saluto