di Raffaele Laurenzi
Il mensile Quattroruote, fondato nel 1956 da Gianni Mazzocchi, è oggi una rivista di servizio, una guida nel vastissimo e complicato mercato dell’auto.
In origine, e fino a tutti gli anni Settanta, ha avuto anche un’altra funzione: ha alimentato il sogno dell’automobile coltivato da milioni di italiani.
Costava 300 lire, dieci volte il Corriere della Sera, eppure ebbe un successo immediato: fu eletta «bibbia dell’automobile»; insegnò a una generazione di italiani la cura dell’automobile; educò milioni di lettori al rispetto del codice della Strada; ne modificò lo stile di vita e alimentò un’aspirazione alla libertà che contribuì in modo determinante all’emancipazione della donna.
Avevo 22 anni quando, nel 1969, ebbi la fortuna di essere accolto come apprendista nella redazione di Quattroruote, la cui casa editrice Domus aveva sede a Milano, in un elegante palazzo dei primi del Novecento, al 15 di via Monte di Pietà. Rimasi a Quattroruote una decina di anni, feci poi altre esperienze, tornai a Quattroruote con nuovi incarichi, fui nominato condirettore della rivista e fui per sedici anni direttore responsabile di Ruoteclassiche, consorella di Quattroruote.
Nelle pagine che seguono racconto fatti e persone di quegli anni.
Buona lettura.
QUELLA MATTINA AL TUSCOLO
Il test più spettacolare di Quattroruote, quello più indicativo della maneggevolezza e dell’agilità di un’automobile, era la corsa in salita. Banco di prova era la strada che da Frascati sale al monte Tuscolo: 4,2 km di curve per 250 metri di dislivello.
Il pilota era sempre lo stesso, il romano Massimo Natili, un ragazzo tanto bravo al volante quanto piacevole in compagnia. La prova si svolgeva all’alba su strada aperta al traffico: qualcosa che oggi sarebbe al limite di una denuncia penale, ma erano gli anni Sessanta, un altro mondo…
Alcuni collaboratori dell’Isam, l’istituto incaricato di svolgere le prove, si piazzavano lungo il percorso per impedire, con la forza della persuasione e nel nome di Quattroruote, che estranei percorressero la strada durante il test. Insomma, una cosa alla buona, senza l’autorizzazione delle autorità, che chiudevano un occhio.
Ma una volta accadde un fatto che non era stato previsto. Fin dalla sera prima, una coppietta si era imboscata, a bordo di una Fiat 600, in una piccola radura lungo la strada. La mattina seguente, sereni e contenti, i due si erano avviati verso valle, proprio mentre Massimo Natili saliva a tutta birra, con grande stridore di gomme e cambi marcia a 5500 giri, al volante di una Fiat 850 Spider, una brillante vettura sportiva carrozzata Bertone.
Si trovarono muso a muso, per fortuna in un tratto rettilineo.
Il pilota della 600, terrorizzato, si buttò tutto a destra con due ruote fuori dell’asfalto. Natili, che non voleva ripetere la prova, si guardò bene dal sollevare il piede dall’acceleratore: gli passò a due dita a 80 all’ora, in piena accelerazione.
L’ingegner Flaviano Moscarini, responsabile dell’Isam, si scusò con eleganza: si fece dare nome e indirizzo del proprietario della 600 (che non osò protestare nel timore che la moglie venisse a sapere…) e gli regalò un abbonamento a Quattroruote.
“La rivista degli automobilisti di oggi e di domani” aveva conquistato un nuovo lettore, honoris causa.
MARCELLO MINERBI
UN GENTLEMAN ALLE PROVE
La sezione «Prove su strada» e «Autonotizie» era la più importante e ambita di Quattroruote, la più vicina a quel feticcio che per noi appassionati è l’automobile. Si trovava in uno stanzone adiacente all’ufficio del capo redattore Giancenzo Madaro e vi lavoravano tre ragazzi appena trentenni: Marcello Minerbi, responsabile, Roberto Bonetto, figlio del pilota Felice che perse la vita al volante di una Lancia D24 durante la Carrera Panamericana del 1953, e Giampiero Anselmi, detto Il Principe per i suoi modi signorili e per la sua bellezza.
Marcello era di famiglia ebrea. Era nato a Ferrara nel 1939, le leggi razziali erano state varate l’anno prima. Non so come la sua famiglia fosse sfuggita a quell’orrore, non gliel’ho mai chiesto, non avevo allora io, ultimo arrivato, abbastanza confidenza per toccare un tasto tanto delicato. Avevo saputo soltanto che la sua famiglia l’aveva passata brutta.
Molti anni più tardi – io ero direttore di Ruoteclassiche, lui di Top Gear – quando seppe che mia moglie si chiamava Fiorentino, nome che ne rivelava l’origine ebrea, Marcello divenne con me più confidenziale. Superò, immagino, quel dubbio che si insinua in tutte le persone che hanno subìto odio, pregiudizi e persecuzioni, e che li porta a guardare gli sconosciuti con diffidenza, a domandarsi: «Chi ho di fronte? Che sentimenti covano nella sua testa?». Forse si era sentito rassicurato da quella coincidenza e subito mi regalò un bel libro sul magnifico palazzo di famiglia a Ferrara, un tempo ricco di marmi, affreschi e opere d’arte: palazzo che la sua famiglia aveva perduto.
Minerbi era un ometto di un metro e sessanta, ma aveva stile, dote che lo alzava una spanna sopra gli altri. Quando parlava di automobili, lo ascoltavo come si ascolta l’oracolo: ciò che diceva lui era per me, allora giovanissimo, oro colato. E, cosa che non guasta, lo diceva bene, senza mai scadere nel luogo comune.
Mi piaceva anche come vestiva: scarpe Church’s, giacca di tweed, camicia button down, cravatta lavorata a maglia, spesso un cardigan o un dolcevita un po’ abbondanti, che gli cadevano bene sul fisico asciutto e proporzionato.
Naturalmente aveva buon gusto anche in materia di automobili. Ufficialmente era lancista e infatti nel 2001 divenne Presidente del Lancia Club, ma secondo me lo era per dovere, per il suo passato sportivo. Sotto sotto preferiva le automobili inglesi. Basti dire che, durante gli anni alla Editoriale Domus come direttore, faceva il pendolare con Asolo, dove risiedeva la famiglia, al volante della sua Jaguar Mark II conservata degli anni Sessanta: 600 chilometri ogni fine settimana su un’auto costruita cinquant’anni prima. Gli chiesi un giorno se avesse considerato l’opportunità di un restauro radicale. «In effetti avrebbe bisogno di una lucidatura» rispose col suo solito humor.
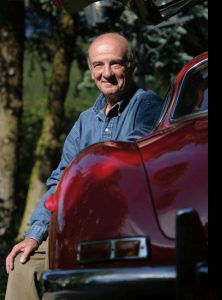 Aveva stile anche nella guida: andava veloce senza correre. Mi spiego: era capace di mantenere medie elevate senza tirare il collo al motore e senza spaventare chi gli sedeva accanto. Frenava e accelerava al momento giusto, cambiava senza strappi, percorreva le curve con progressione e precisione, alla velocità giusta. Aveva per l’automobile quel rispetto che derivava dalla conoscenza della meccanica.
Aveva stile anche nella guida: andava veloce senza correre. Mi spiego: era capace di mantenere medie elevate senza tirare il collo al motore e senza spaventare chi gli sedeva accanto. Frenava e accelerava al momento giusto, cambiava senza strappi, percorreva le curve con progressione e precisione, alla velocità giusta. Aveva per l’automobile quel rispetto che derivava dalla conoscenza della meccanica.
Il suo curriculum di pilota era onorevole: aveva cominciato sui kart, si era poi cimentato in gare di moto e auto, in pista e in salita, alla guida di una Volpini formula 3 con motore Lancia, di una Fulvia HF, di una moto Triumph Trident e di altre macchine sportive.
Non era un bravo scrittore (lo sarebbe diventato), nessuno lo era a Quattroruote, ma si spiegava bene e si faceva leggere, che era poi la cosa più importante in una rivista specializzata, che non concedeva molto al racconto e alla creatività.
Gli riusciva male fare il modesto. Era così poco credibile in quella veste che la sua modestia finiva col rimarcare il distacco tra sé e gli altri. Se lo poteva permettere e lo ammiravo per questo. Provai perciò un’autentica emozione quando, un giorno di fine ottobre 1970, si affacciò alla porta e disse, rivolgendosi al mio caposervizio Mastrostefano: «Domani riporto la Lamborghini Espada a Sant’Agata. Hai niente in contrario se ti porto via il Raffaele per una giornata? Lui mi segue con la 127 gialla della prova di durata, così poi mi riporta a Milano».
Mastrostefano annuì e la mattina seguente partimmo. Non ricordo come e da chi fummo ricevuti, probabilmente da un addetto stampa. Ricordo che visitammo lo stabilimento, dopodiché ci portarono in una saletta disadorna, attigua alla mensa dell’azienda, dove ci avrebbero servito il pranzo. Dieci minuti più tardi entrò Ferruccio Lamborghini, accompagnato da una bella signora e da uno spilungone in tuta. Si sedettero con noi, si mangiò pollo arrosto con patate e naturalmente si parlò di macchine e motori.
«Allora, ti è piaciuta l’Espada?» chiese Lamborghini a Minerbi.
E qui scoprii una dote di Marcello che non sospettavo: la diplomazia. Fu capace di spiegare tutte le evidenti contraddizioni del progetto dando l’impressione di lodarlo, al punto che Ferruccio gli dette ragione su tutto. Perfino sulla profezia di Marcello secondo il quale il successo di vendita dell’Espada non sarebbe bastato a questo modello per restare scolpito nella testa degli appassionati. Invece la Miura sarebbe passata direttamente dall’attualità alla storia. A quel punto indicò me: «Vede questo ragazzo? Poco fa mi diceva che per lui la Miura rimarrà sempre la più bella macchina del mondo. Meriterebbe di fare adesso un bel giro sulla Miura…»
A quel punto, lo spilungone biondo si alzò e mi mise una mano sulla spalla: «Vieni con me» disse con perfetto accento inglese.
«Come ti chiami?» mi chiese mentre ci avviavamo verso il cortile.
«Raffaele. E tu?»
«Bob. Bob Wallace»
La Miura era lì fuori, carrozzeria pasticciata, un colore indeciso, segni di modifiche, abitacolo vissuto… Bob mi anticipò: «Questo è il “muletto”. Non farci caso, allaccia le cinture».
Cominciò così il tour sulle strade che attraversano la campagna intorno a Sant’Agata: strette tra due fossi, ma per fortuna deserte.
Bob andava come se fossimo a Monza. A un certo punto infilammo un rettilineo che terminava con una curva a 90 gradi che portava su un ponticello delimitato da due lame di guard rail. Ci stavamo avvicinando, chissà, a 200 all’ora, forse di più. Pensai: è finita, stavolta non ce la possiamo fare. Puntai i piedi e mi attaccai al maniglione. A un soffio dal presunto impatto, frenata tosta, due cambi di marcia in un secondo, virata secca in barba alla forza centrifuga, uscita dalla curva in piena accelerazione con motore a settemila giri e il pollo un po’ rinseccolito della mensa che tentava di risalire lungo l’esofago.
«Cazzo santo, ma chi è questo?» mi domandai, felice di essere ancora tutto intero.
Chi fosse Bob Wallace me lo spiegò poi Minerbi durante il viaggio di ritorno. Bob non era americano come pensavo: era nato a Auckland, Nuova Zelanda. E non era soltanto un bravo pilota: era un ingegnere specializzato in macchine ad alte prestazioni. Nel suo curriculum c’erano esperienze negli Stati Uniti e in Inghilterra. Aveva poi lavorato alla Lotus, aveva preparato Chevrolet Corvette e Maserati Birdcage, era stato ingaggiato dalla Scuderia Serenissima perché rendesse più competitive le Ferrari GTO e 250 Testa Rossa; in Formula 1 aveva curato la messa a punto della Ferrari di Phil Hill…
Ferruccio Lamborghini cercava un capo collaudatore a cui affidare la messa a punto dei prototipi.
Wallace, dal canto suo, cercava qualcosa di più di un team sportivo, per esempio un costruttore, ancorché piccolo, dove svolgere il compito di trouble shooter.
Si incontrarono nel 1963 e si piacquero. Wallace si mise subito all’opera sulla 350 GTV, ma il lavoro dove avrebbe espresso al meglio le sue doti di tecnico fu la Miura, che – mi disse Minerbi – lui avrebbe voluto portare in pista a Monza, a Sebring, a Le Mans. Ma da quell’orecchio Ferruccio Lamborghini, che pure metteva a disposizione di Bob le persone e le risorse che lui voleva, non ci sentiva.
avrebbe espresso al meglio le sue doti di tecnico fu la Miura, che – mi disse Minerbi – lui avrebbe voluto portare in pista a Monza, a Sebring, a Le Mans. Ma da quell’orecchio Ferruccio Lamborghini, che pure metteva a disposizione di Bob le persone e le risorse che lui voleva, non ci sentiva.
Molti anni più tardi – era il 2013 – nel cortile dell’Editoriale Domus incrociai Minerbi, che mi disse con tono di rimprovero: «Mi aspettavo di leggere qualcosa su Bob Wallace sul numero di novembre del tuo Ruoteclassiche…». Non capii, e allora aggiunse: «Come? Non sapevi che è morto?»
Aveva ragione, Bob Wallace meritava un servizio. Minerbi non aveva finito di darmi lezioni. Lo chiamai un paio di volte dopo che si era ritirato ad Asolo. Troppo poche e troppo tardi. Morì in silenzio nel 2017.
LO SCHIAFFO DI ANAGNI
Primi anni Settanta, le vendite della Fiat 125 Special accusavano stanchezza, bisognava studiare qualcosa per richiamare l’attenzione su quel modello, ormai a fine carriera. Dopo la classica «prova su strada», la 125 Special era tornata sulle pagine di Quattroruote nella versione con cambio automatico a tre marce e in quella con condizionatore (i due accessori erano incompatibili tra loro per motivi di ingombro: si doveva optare per l’uno o per l’altro). Insomma, quella macchina l’avevamo cucinata in tutte le salse: che cosa potevamo proporre ancora, che non fosse il solito raid?
tre marce e in quella con condizionatore (i due accessori erano incompatibili tra loro per motivi di ingombro: si doveva optare per l’uno o per l’altro). Insomma, quella macchina l’avevamo cucinata in tutte le salse: che cosa potevamo proporre ancora, che non fosse il solito raid?
Raffaele Mastrostefano, allora mio caposervizio, ebbe l’idea di una prova di traino di roulotte e la Fiat accettò. Fece bene la Fiat, perché il caravanning si stava espandendo anche in Italia, sebbene con ritardo rispetto alle nazioni del Nordeuropa, e la 125 Special, una 1600 a cinque marce e trazione posteriore, sembrava proprio indicata per quella mansione.
La roulotte ce la fornì la Laverda. Mi pare fosse il modello 360 N, che andai a ritirare io stesso a Gardolo, presso Trento, dove la Laverda si era trasferita, avendo acquistato lo stabilimento ex Caproni.
(Breve digressione: la Laverda costruiva a Gardolo un aereo monomotore a due posti, il Super Falco, progetto dell’ingegner Frati, che si diceva avesse prestazioni eccellenti. Non me ne intendo, ma a giudicare dal piccolo aviocampo di fronte allo stabilimento, disteso su un altopiano chiuso da alte montagne, ci volevano sicuramente eccellenti doti di salita e di maneggevolezza per venirne fuori e per atterrarvi indenni.)
Le prove si svolgevano ad Anagni, Frosinone, dove l’Isam, Istituto Sperimentale Auto e Motori, fondato dall’editore Gianni Mazzocchi e diretto da suo cugino Flaviano Moscarini, ingegnere e giornalista (era anche direttore di Auto Italiana), aveva da poco inaugurato una nuova sede.
Per la prova di velocità in salita, come abbiamo già raccontato, si andava al Tuscolo. Per la prova di velocità massima, che una volta si faceva all’alba sulla strada per Ostia, troppo pericolosa, si andava sull’autostrada per Napoli, che offriva lunghi tratti rettilinei dove – abusivamente – era stata misurata e segnalata con vernice bianca una base con pendenza quasi zero e lunga, se ricordo bene, duemila metri.
L’autostrada, a due corsie, era spesso battuta dal vento e trafficata, motivo per cui a volte il test della velocità massima doveva essere ripetuto anche tre volte nei due sensi di marcia.
I test di accelerazione, ripresa, frenata e consumo a velocità costante si svolgevano invece su una base misurata ricavata sulla pista in cemento dell’aeroporto di Ciampino. Qui si facevano anche i test di maneggevolezza (clotoide, cerchi, sorpasso) da cui, per motivi intuibili, la nostra 125 Special con rimorchio era stata esonerata (anche le roulotte ci venivano consegnate in prestito, perciò ci sembrava educato restituirle intatte…).
Se tutto andava bene, e se non pioveva, l’intero ciclo di prove impegnava la squadra dei tecnici Isam per tre o quattro giorni. Nel nostro caso, ce la saremmo cavata in due. La mattina del secondo giorno, si sarebbero svolti i test conclusivi: accelerazione, frenata e consumo.
Giulio Pusinanti, storico collaudatore di Quattroruote, dispose il convoglio Fiat 125 Special e rimorchio sulla linea di partenza, una striscia bianca che al passaggio della vettura avrebbe attivato una fotocellula e questa un cronometro. Suo delicato compito era strappare il tempo migliore sulla base del chilometro senza fottere la frizione.
Il motore era caldo, gli strumenti di rilevazione erano pronti:
un tecnico dell’Isam si chinò sul finestrino dell’auto, scambiò due parole col Pusinanti, poi abbassò il braccio: via! La povera 125 Special, acceleratore al chiodo, alzò il muso; le ruote posteriori accennarono uno slittamento, un attimo più tardi vidi il tecnico dell’Isam piroettare su se stesso come un pattinatore sul ghiaccio: si era preso lo spigolo del caravan sulla faccia, barcollava come la trottola che sta per cadere e io, che gli ero dietro, allungai le braccia per sostenerlo.
«Non è niente, non è niente» si affrettò a rassicurarmi. Ma la sberla era stata forte: il ragazzo aveva lo spigolo della roulotte stampigliato sulla faccia, dalla tempia alla guancia passando per l’orecchio, che un po’ sanguinava.
Al momento del «via!», quel poveretto si era dimenticato del rimorchio, una quarantina di centimetri più largo della Fiat 125.
 «Spero di non aver scassato la roulotte» aggiunse ironicamente. Lo rassicurai, la roulotte era intatta. Ma sullo spigolo c’era un ciuffetto di capelli sanguinolento…
«Spero di non aver scassato la roulotte» aggiunse ironicamente. Lo rassicurai, la roulotte era intatta. Ma sullo spigolo c’era un ciuffetto di capelli sanguinolento…
Lo storico ceffone, che ad Anagni Sciarra Colonna affibbiò nel 1303 a papa Bonifacio VIII con la manona guantata di ferro, dovette essere una carezza, al confronto dello schiaffo di una roulotte Laverda di 600 chili.
GIANNI MAZZOCCHI
LO RICORDO COSÌ
Su Gianni Mazzocchi, editore geniale, fondatore e primo direttore di Quattroruote, sono stati scritti dei libri. Ma io lo ricordo soprattutto per due episodi: piccoli, ma importanti per me e indicativi dello spirito liberale dell’uomo.
Era il 1973, avevo superato a giugno l’esame che mi avrebbe permesso di iscrivermi all’albo dei giornalisti professionisti. Decisi di premiarmi, di farmi un regalo che desideravo da tempo: al Circolo Est Verbano, sul Lago Maggiore, mi ero invaghito di uno Snipe costruito negli anni 50, una barca a vela in compensato marino, con albero e boma di legno lucido, vele nuove, nemmeno una vite a vista. Ai miei occhi, un’opera d’arte.
Ma ero in bolletta. Chiesi perciò alla Domus un prestito di 300.000 lire da restituire senza interessi in dodici rate di 25.000 lire, che sarebbero state detratte dalla mia retribuzione mensile.
Arrivò dicembre: nella busta della tredicesima, che allora si pagava con moneta sonante a metà  dicembre, c’era un biglietto: «Abbiamo il piacere di comunicarle che, in vista del Natale, il dott. Mazzocchi ha deciso di abbonarle il debito residuo».
dicembre, c’era un biglietto: «Abbiamo il piacere di comunicarle che, in vista del Natale, il dott. Mazzocchi ha deciso di abbonarle il debito residuo».
Neppure mi conosceva…
Imparò a conoscermi però alcuni mesi più tardi, quando mi capitò di fare un errore da licenziamento. Nel curare una cartina geografica dell’Europa, applicai la sigla DDR, Repubblica Democratica Tedesca, nello spazio della Germania federale. E misi la D della Germania libera nello spazio della Germania comunista… Non so spiegarmi come fosse potuto accadere, perché mi erano ben chiari i confini della Germania Est: l’Oder a Oriente e un lungo tratto dell’Elba a Occidente. Però accadde.
In redazione nessuno se ne accorse e l’errore uscì sulla rivista. Poteva tranquillamente essere perdonato e dimenticato dai lettori che se ne fossero accorti. Il guaio fu che se ne accorse per primo Gerhard Richard Gumpert (1910-1987), fondatore a Verona dell’Autogerma, società importatrice degli autoveicoli Volkswagen in Italia.
Gumpert alzò la cornetta e chiamò Gianni Mazzochi, suo vecchio amico. Venni poi a sapere che la telefonata arrivò dopo le 10 di sera: orario inconsueto, perciò indicativo del grado di indignazione dell’imprenditore tedesco…
La mattina seguente, il fattorino della Presidenza recapitò al mio caposervizio Mastrostefano la fotocopia della pagina incriminata, rubrica Posta, con una clip e un biglietto: «C’è una quinta colonna nella redazione di Quattroruote. Voglio sapere il nome».
«Addio, qui mi licenziano!» pensai. Decisi allora di giocare d’anticipo. Chiamai la signora Massara, segretaria storica e onnipotente dell’editore, e l’implorai di farmi salire nello studio di Mazzocchi. Un’ora più tardi, per la prima volta da quando ero alla Domus, mi affacciai timidamente nel grande ufficio dell’editore e direttore: «Permesso?», chiesi con poca voce.
«E lei chi è?»
«Sono la quinta colonna…»
Si mise a ridere: «Lasci perdere. Torni al suo lavoro e faccia attenzione».
Ero stato graziato.
Immagini: Per gentile concessione Archivio Quattroruote
Immagine di copertina: composizione di foto storiche della testata anni 50-70

- Il bancario - 8 Luglio 2024
- La “cura” di Teo - 24 Giugno 2024
- Noemi - 17 Giugno 2024





